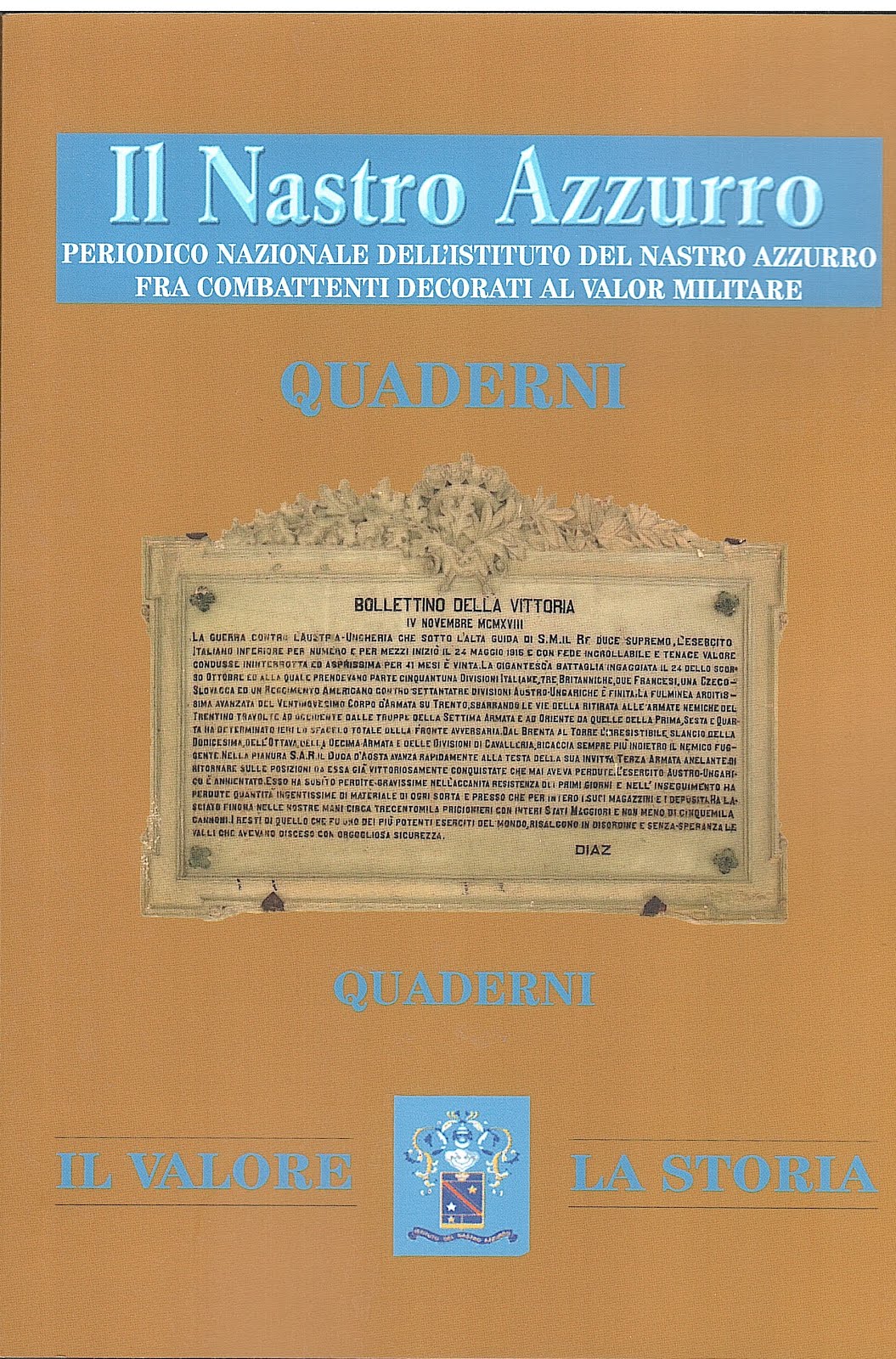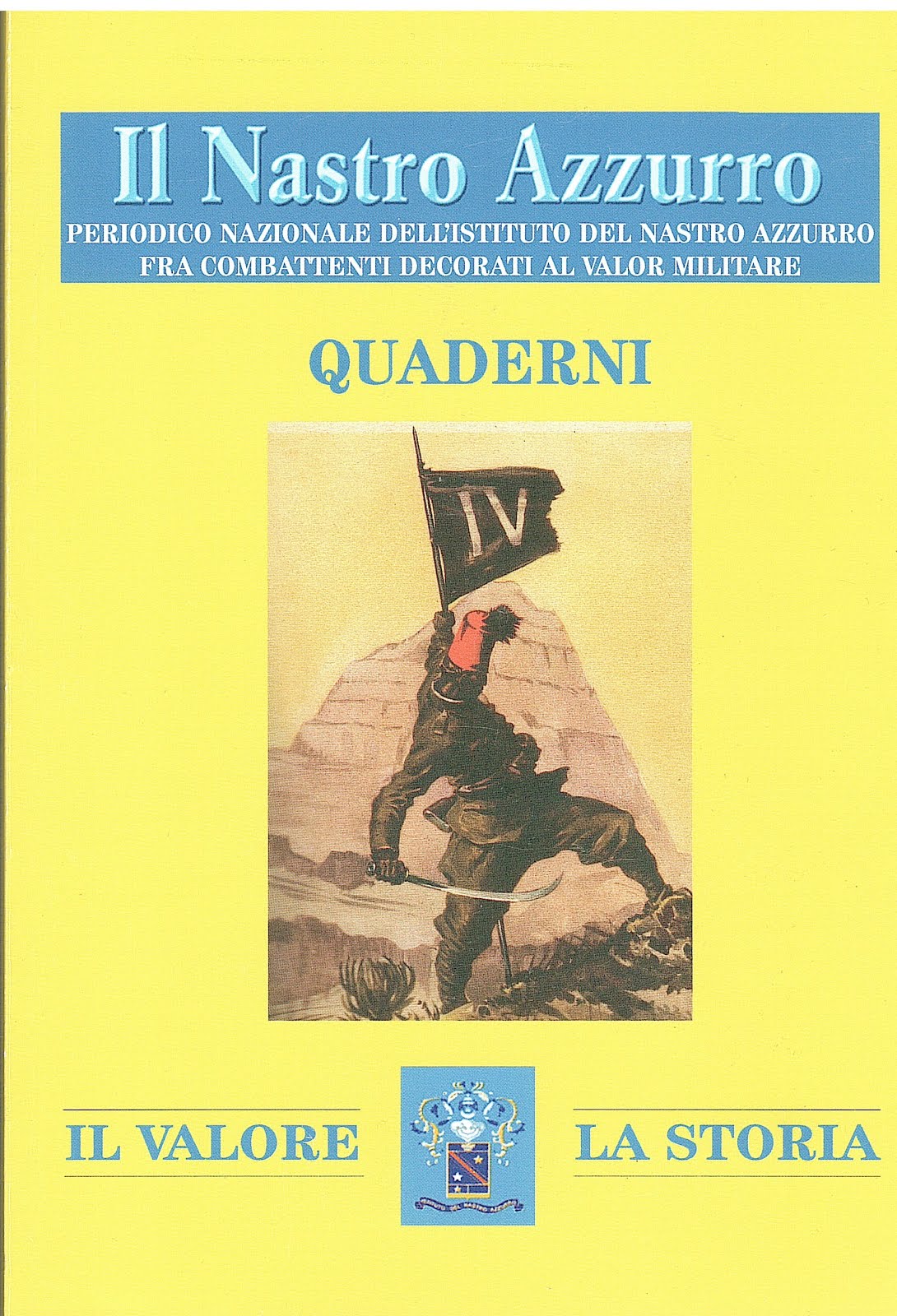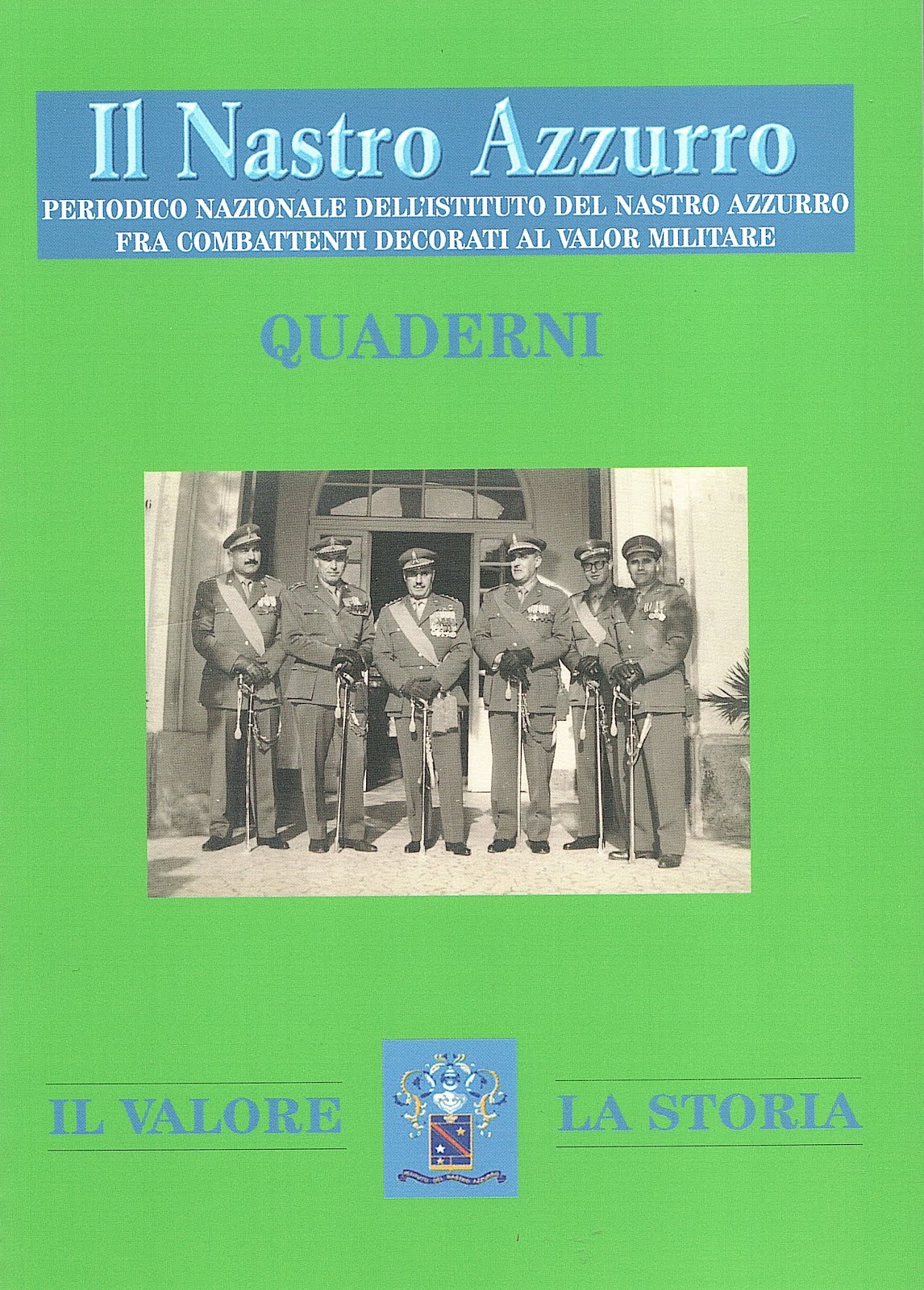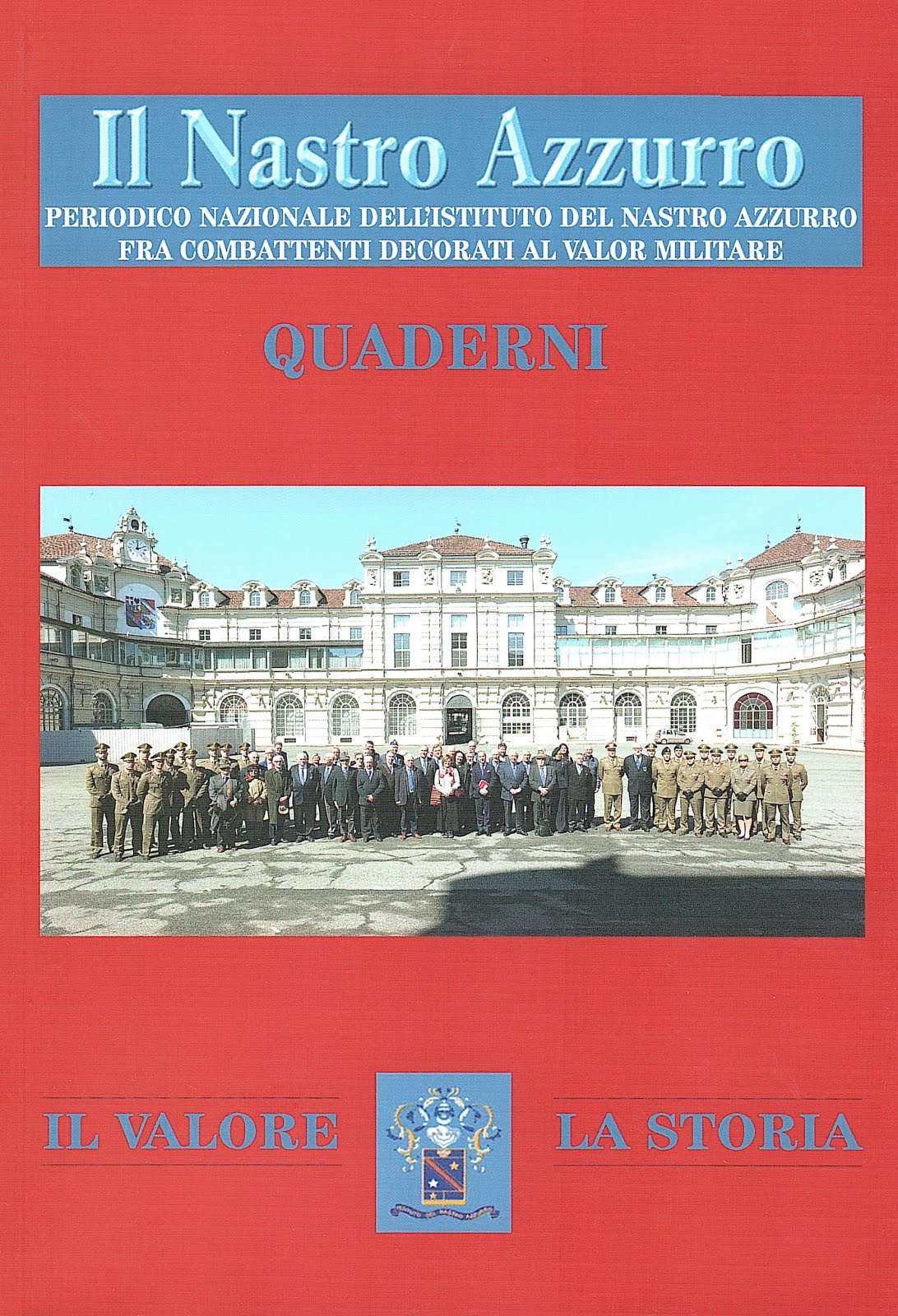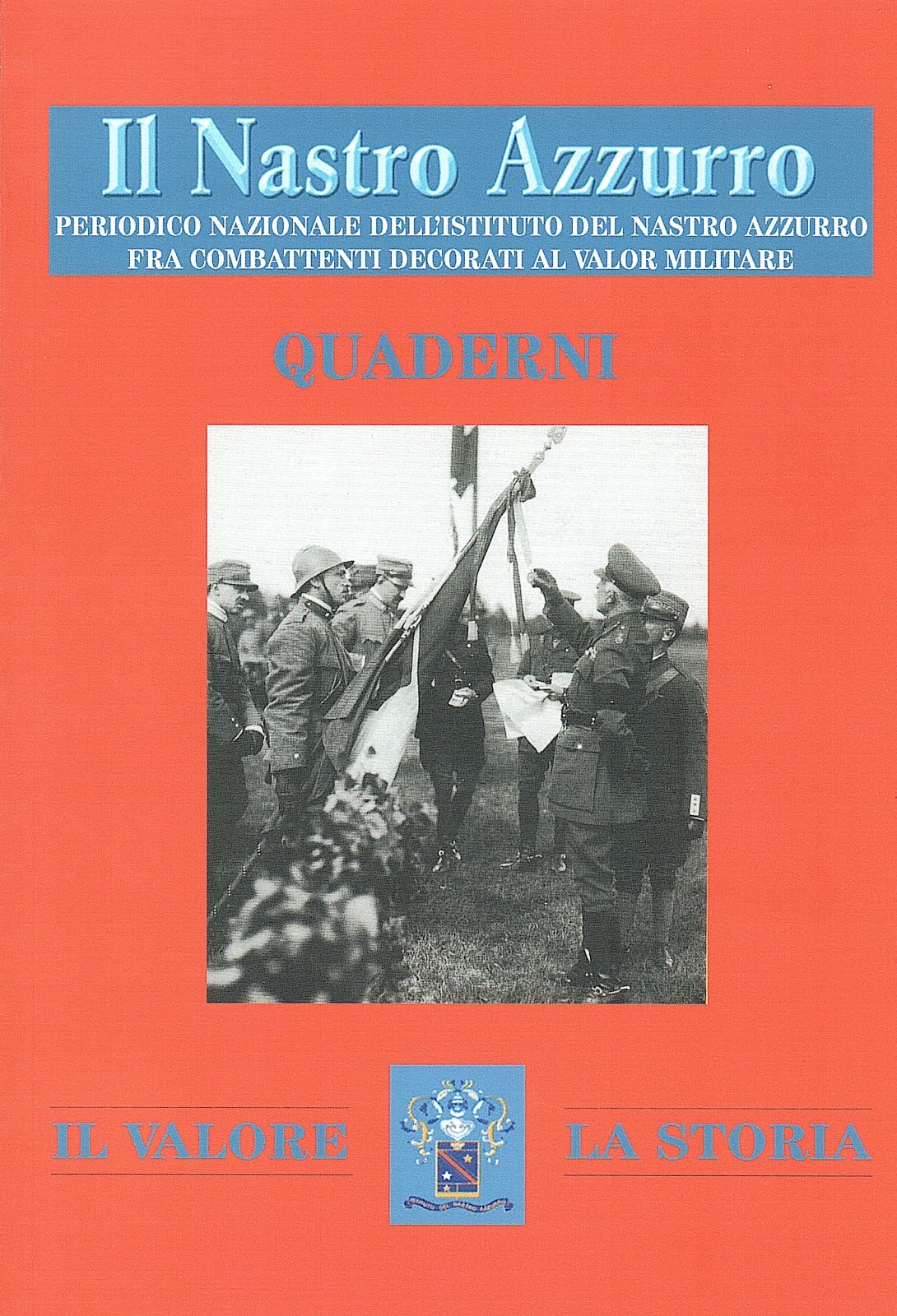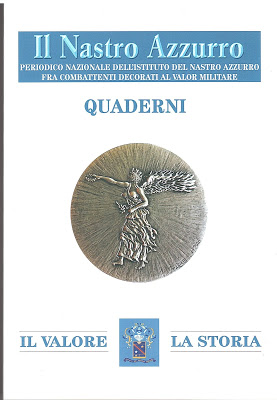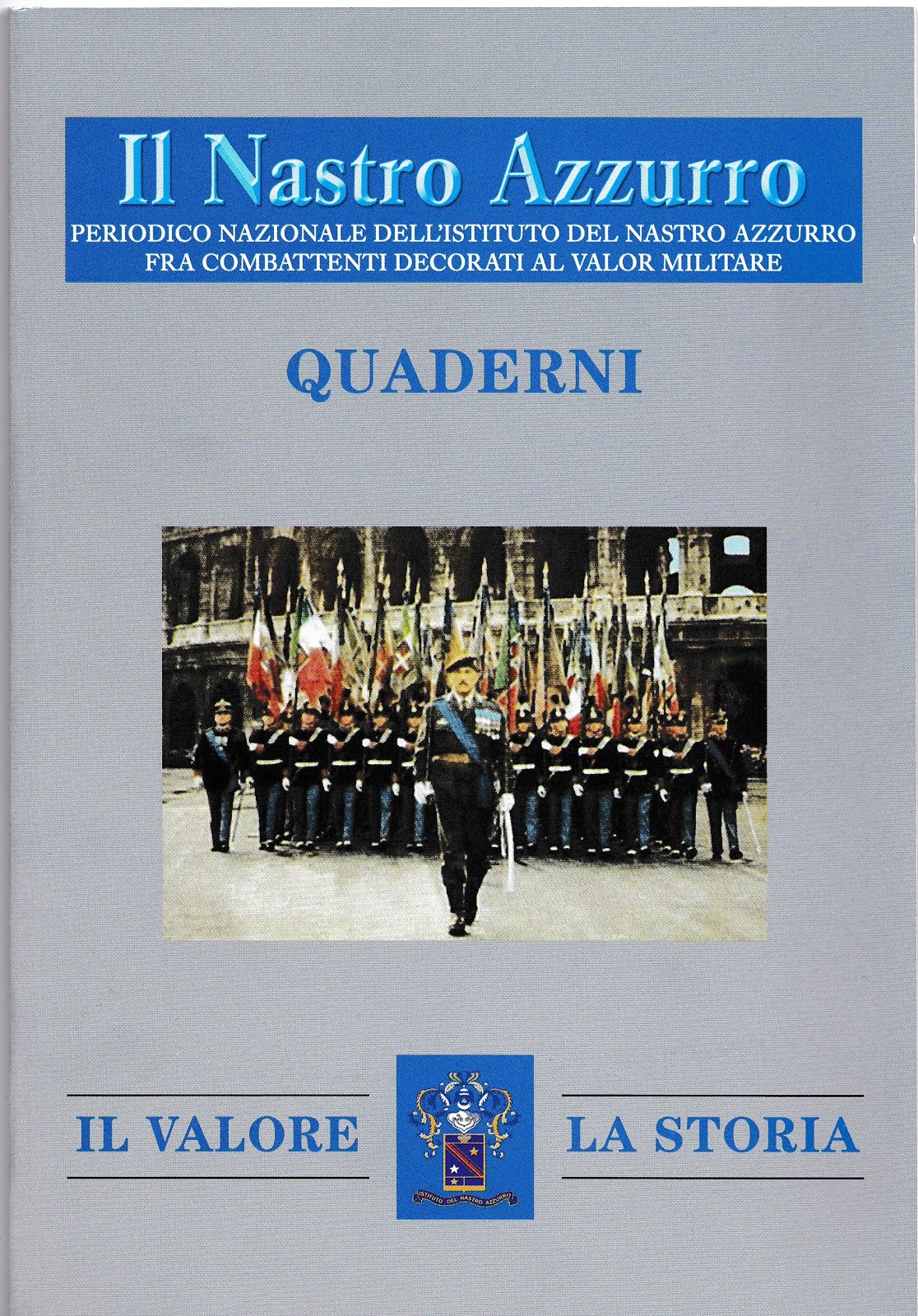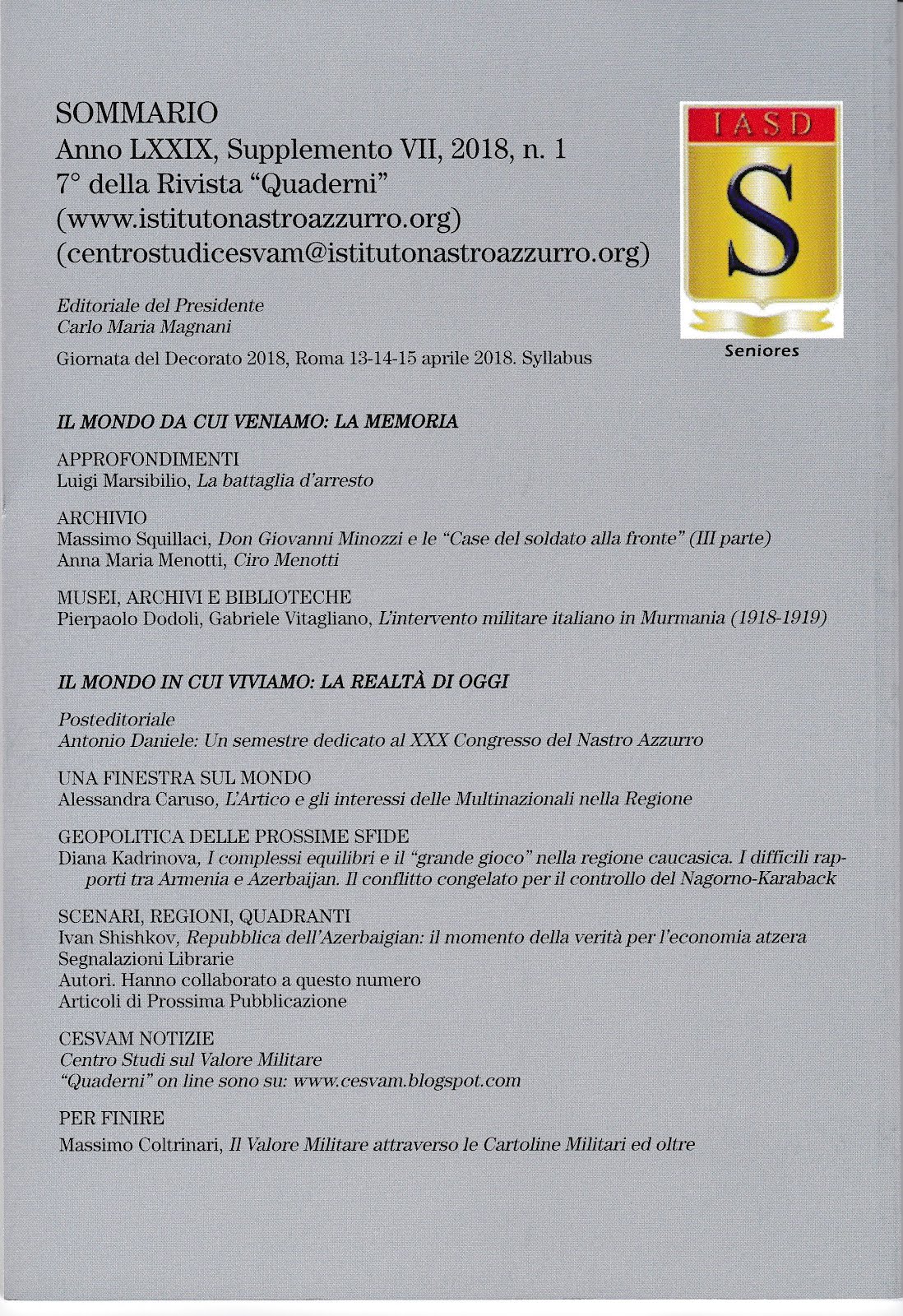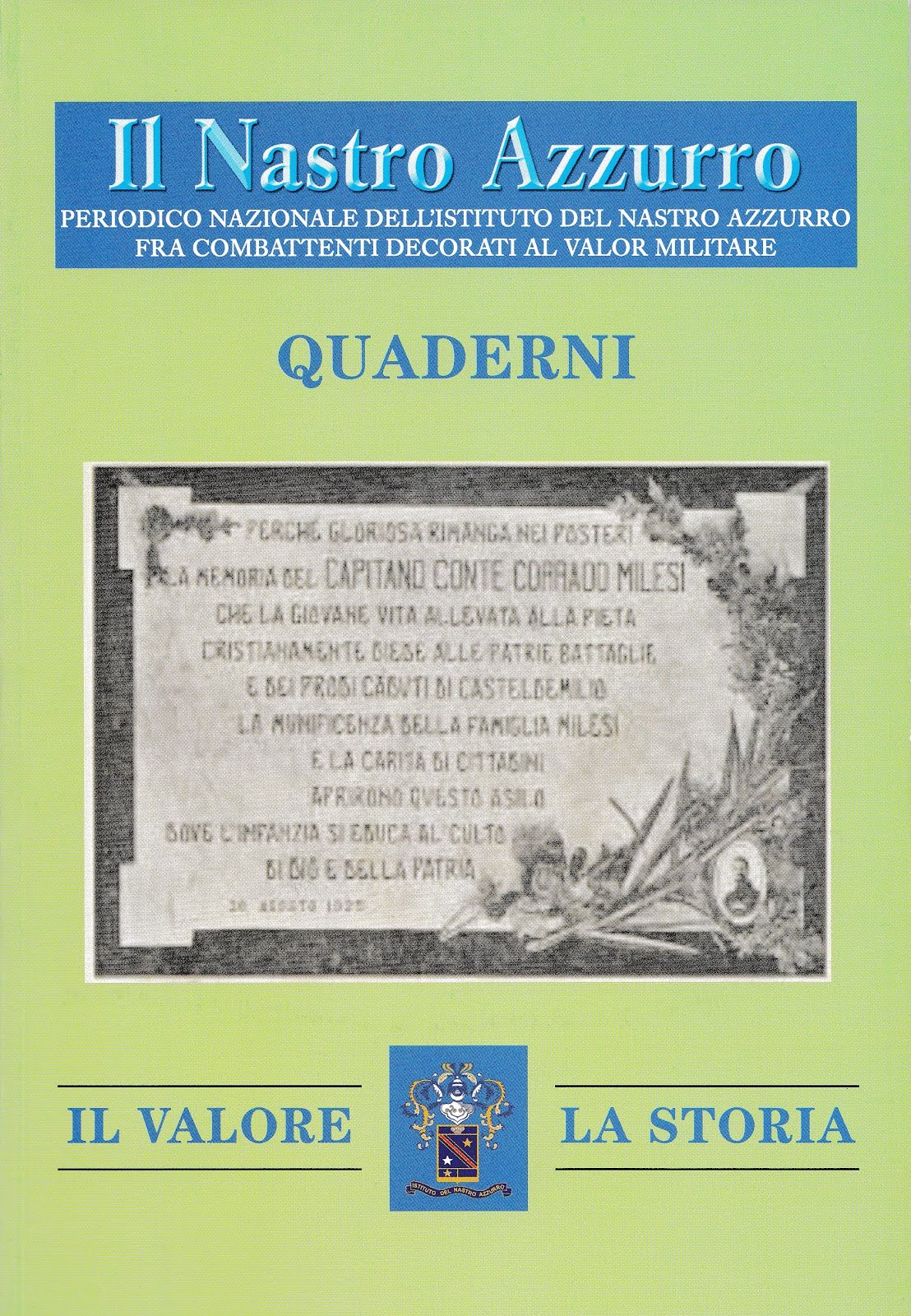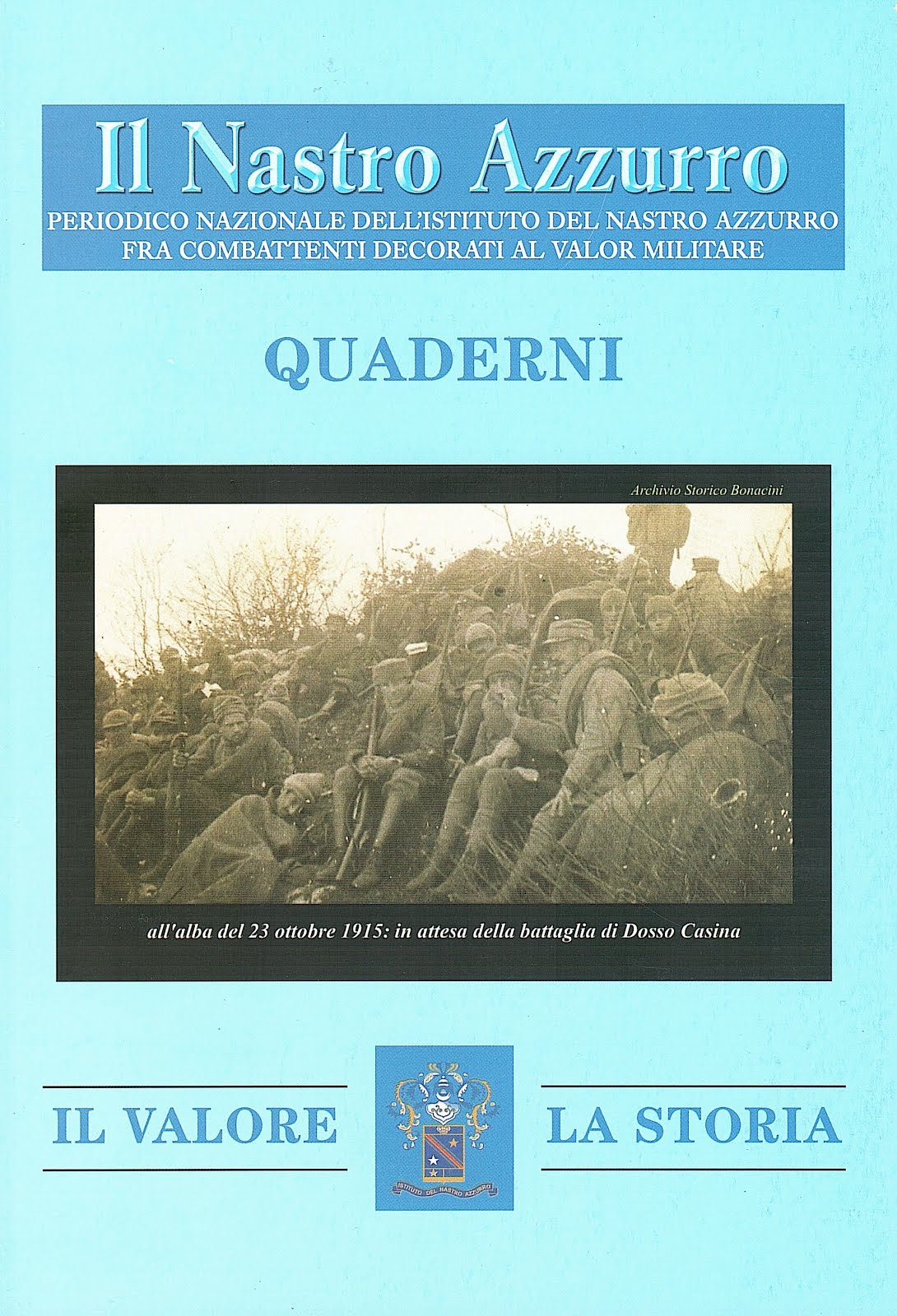La definizione di sicurezza alimentare comunemente accettata a livello internazionale è quella elaborata nel World Food Summit del 1996, e cioè una situazione in cui: “tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti, che garantiscano le loro necessità e preferenze alimentari, per condurre una vita attiva e sana”. Lo sradicamento della malnutrizione è uno degli obiettivi basilari della politica di Sicurezza Alimentare e Nutrizionale nel mondo. Il principale obiettivo di sviluppo fissato a livello internazionale per il nuovo millennio è l’eliminazione della povertà. In passato gli interventi di sicurezza alimentare erano tra gli ultimi punti dell’agenda politica internazionale e la problematica era affrontata quasi esclusivamente nelle situazioni di emergenza, mentre oggi le politiche per la sicurezza alimentare siano diventate un elemento fondamentale delle strategie di sviluppo delle aree arretrate.
Nel 1996 il World Food Summit si è posto l’obiettivo ambizioso di dimezzare il numero dei sottonutriti al 2015, riducendolo – se così si vuol dire – a circa 400 milioni di persone sottonutrite (essendo stimato in oltre 840 milioni il numero di quelle che risultano esserlo nel 2013).
Secondo le proiezioni della Fao i progressi compiuti verso la riduzione della fame sono troppo lenti per raggiungere la soglia fissata dal World Food Summit del ‘96. Se le attuali tendenze non si modificheranno, nei Paesi in via di sviluppo avremo 170 milioni in più di persone sottonutrite rispetto all’obiettivo stabilito dal Summit e i divari saranno particolarmente severi in termini assoluti per l’Africa Sub-Sahariana e il Sud Asia. Per il futuro abbiamo sicuramente una certezza: nonostante i progressi compiuti verso l’eliminazione della fame, nessuno degli obiettivi posti dalla comunità internazionale sarà sicuramente raggiunto.
Negli ultimi decenni si è verificata un’inversione di tendenza nella formulazione originaria dell’economia globale: prima avevamo un basso costo del cibo ed una sostanziale autonomia alimentare dei maggiori Paesi del Terzo Mondo (arabi e dell’Africa sub Sahariana).
Oggi, per la prima volta dopo la fine del mondo bipolare, le aree periferiche si trovano inserite, in posizioni di debolezza, in un mercato del cibo globale che va verso un’industrializzazione che non è quella del sistema di fabbrica.
Oggi tutto cambia: c’è la globalizzazione, l’aumento demografico, la penetrazione dei mercati mondiali nell’agrifood africano ed asiatico, l’aumento dei prezzi dei prodotti non alimentari.
I nuovi equilibri sono semplici:
- L’espansione dei mercati interni a prezzi elevati – da un lato;
- Lo stretto collegamento del costo del cibo prodotto nel Terzo Mondo con quello degli idrocarburi, che servono sia come fertilizzanti che per gestire le coltivazioni ed i trasporti – dall’altro.
Quindi:
- più aumenta la bolletta energetica del Terzo Mondo, più diminuisce la disponibilità di cibo da acquistare sull’open market globale;
- più aumentano la popolazione locale e l’asimmetria con cui è distribuita tra città e campagne, più diminuisce la produttività dei suoli ed aumenta la schiavitù degli usi e consumi di tipo occidentale da parte dei nuovi poveri nelle periferie del mondo, coi relativi costi.
In termini strettamente quantitativi, c’è cibo a sufficienza per sfamare l’intera popolazione mondiale che attualmente è di oltre 7 miliardi di persone. E’ corretto, dunque, chiedersi perché nel mondo – nel 2013 – 842 milioni di persone – circa il 15% dell’intera popolazione del pianeta – soffrono la fame; perché 1 persona su 8 è affamata; perché nei PVS 1 bambino su 6 è sottopeso. Oggi si calcola che, nel mondo, muoiano ogni anno 40 milioni di persone per cause legate alla fame o alla malnutrizione e sottonutrizione. Eppure il Diritto all’alimentazione è uno dei principii sanciti nella “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” del 1948.
Insomma è giusto chiedersi perché esiste la fame.
Le cause sono diverse, tutte importanti allo stesso modo, e su ciascuna di esse dovrebbe essere operato un correttivo ai competenti livelli della gestione politica dei vari sistema-paese e globali.
Una delle cause della persistenza della fame è senz’altro l’aumento dei disastri naturali, come le inondazioni, le tempeste tropicali e i lunghi periodi di siccità, con terribili conseguenze per la sicurezza alimentare nei paesi poveri e in via di sviluppo. I cambiamenti climatici causati dalle emissioni nocive (gas serra) e dai cambi di uso del suolo hanno provocato il riscaldamento degli oceani, la fusione dei ghiacci e la riduzione della copertura nevosa, l’innalzamento del livello medio globale marino e modificato alcuni estremi climatici, favorendo l’aumento della temperatura media del globo (+1-2,3%) che causa siccità . Secondo l’IPCC “Le emissioni di gas serra che continuano a crescere provocheranno ulteriore riscaldamento nel sistema climatico. Il riscaldamento causerà cambiamenti nella temperatura dell’aria, degli oceani, nel ciclo dell’acqua, nel livello dei mari, nella criosfera, in alcuni eventi estremi e nella acidificazione oceanica. Molti di questi cambiamenti persisteranno per secoli”. L’estensione dei ghiacci continuerà ad assottigliarsi, tanto che probabilmente sarà possibile una fusione totale dei ghiacciai artici già entro il 2050. La siccità è oggigiorno la causa più comune della mancanza di cibo nel mondo. Nel 2006, siccità ricorrenti hanno causato il fallimento dei raccolti e la perdita di ingenti quantità di bestiame in Etiopia, Somalia e Kenia. In molti paesi, il cambiamento climatico sta inasprendo le già sfavorevoli condizioni naturali: gli agricoltori poveri in Etiopia o Guatemala, in assenza di piogge, tendono generalmente a vendere il bestiame per coprire le perdite ed acquistare cibo. Ma anni consecutivi di siccità, sempre più frequenti nel Corno d’Africa e nel Centro America, stanno mettendo a dura prova le loro risorse.
Altra causa della persistenza della fame nel mondo sono certamente i Conflitti. Dal 1992 la percentuale delle crisi alimentari causate dall’uomo, di breve o lunga durata, è passata dal 15 al 35% e molto spesso sono i conflitti ad esserne la causa scatenante.
Dall’Asia all’Africa all’America Latina, i conflitti costringono milioni di persone ad abbandonare le proprie case, causando emergenze alimentari globali. I dati della FAO indicano che i disastri indotti dall’uomo rappresentavano non più del 10% delle emergenze totali a metà degli anni ‘80, mentre hanno superato il 50% all’inizio del nuovo millennio. Sempre la FAO stima che tra il 1970 e il 1997 le perdite medie annue nella produzione agricola causate dalla guerra (senza considerare le perdite nella dotazione di capitale e altri costi indiretti) siano state pari a 4,3 miliardi di USD, registrando poi un trend crescente. Lo stesso ammontare di risorse finanziarie sarebbe stato sufficiente ad assicurare adeguata nutrizione a 330 milioni di persone povere malnutrite e si sarebbero risparmiate molte risorse finanziarie destinate agli aiuti alimentari d’emergenza.
Solo 3 dei 56 principali conflitti armati registrati tra il 1990 e il 2000 sono stati di tipo inter-statuale, in tutti gli altri casi si è trattato di conflitti interni, anche se in ben 14 casi sono state assoldate forze militari straniere da una o più parti in conflitto. Africa ed Asia sono i continenti maggiormente interessati sia dai nuovi conflitti che dall’insicurezza alimentare. La pace e lo sviluppo e la lotta alla povertà e alla fame si rafforzano reciprocamente: la costruzione di un mondo di pace si lega indissolubilmente ad un mondo libero dalla fame.
Il recente passato ha sperimentato molto frequentemente tragedie alimentari che si sono intrecciate al venir meno di condizioni di pace e di sicurezza. Dal 2004, oltre 1 milione di persone ha dovuto abbandonare le proprie abitazioni a causa del conflitto nel Darfur (regione del Sudan), provocando una grave crisi alimentare, in un territorio dove solitamente non mancavano piogge e buoni raccolti. In periodo di guerra il cibo diventa un’arma: i soldati inducono alla fame i nemici rubando o distruggendo loro cibo e bestiame e colpendo sistematicamente i mercati locali. I campi vengono minati ed i pozzi contaminati per costringere i contadini ad abbandonare la propria terra. E’ un dato di fatto che dove c’è una guerra in corso la percentuale di persone che soffrono la fame aumenta; mentre la malnutrizione diminuisce nelle zone più pacifiche.
Ulteriore causa della fame nel mondo è la povertà. Nei paesi in via di sviluppo gli agricoltori spesso non possono permettersi l’acquisto di sementi sufficienti a produrre un raccolto che soddisferebbe i bisogni alimentari delle proprie famiglie. Agli artigiani mancano i mezzi per acquistare il materiale necessario a sviluppare le proprie attività. Gli indigenti non hanno abbastanza denaro per comprare o produrre il cibo necessario al sostentamento delle proprie famiglie. Essi diventano, quindi, troppo deboli per produrre il necessario per procurarsi più cibo. I poveri sono affamati ed è la stessa fame ad intrappolarli nella povertà, che diventa un circolo vizioso.
C’è, poi, il problema delle infrastrutture agricole: nel lungo periodo, il miglioramento delle tecniche agricole rappresenta una delle soluzioni alla povertà ed alla fame. Secondo il Rapporto “Lo Stato dell’insicurezza alimentare nel mondo”, pubblicato dalla FAO nel 2013, tutti i paesi che sono sulla buona strada per raggiungere il primo Obiettivo di Sviluppo del Millennio condividono una crescita agricola migliore della media. Tuttavia, ancora troppi paesi in via di sviluppo non hanno infrastrutture adeguate a sostenere l’agricoltura, come strade, depositi e canali d’irrigazione. Di conseguenza, i costi dei trasporti sono alti, mancano le strutture per l’immagazzinamento, e le risorse idriche sono inaffidabili. Tutto ciò limita lo sviluppo agricolo e l’accesso al cibo. Inoltre, anche se la maggioranza dei paesi in via di sviluppo dipende dall’agricoltura, le politiche economiche dei Governi si concentrano spesso sullo sviluppo urbano.
Ulteriore elemento è dato dall’eccessivo sfruttamento dell’ambiente: tecniche agricole arretrate, deforestazione ed eccessivo sfruttamento dei campi e dei pascoli stanno mettendo a dura prova la fertilità della terra. I terreni coltivabili del nostro pianeta sono, costantemente e sempre più, in pericolo di erosione, salinazione e desertificazione. La Rivoluzione verde che c’è stata tra il 1960 e il 1990 nei paesi in via di sviluppo ha portato ad un boom nella produttività agricola. In quel periodo, la produzione di grano, riso e mais è stata più che raddoppiata, particolarmente in America Latina ed in Asia.
I fattori che hanno consentito questo enorme incremento della produzione agricola sono stati:
- l’uso massiccio di fertilizzanti e pesticidi,
- il miglioramento del metodo di irrigazione,
- l’utilizzo di macchinari per l’automazione di tutti i processi agricoli,
- le selezioni dei semi, che hanno reso possibile lo sviluppo di colture ad alta produttività.
L’aumento della produttività, però, ha avuto il suo costo e non ha risolto il problema della fame nel mondo. Infatti, con la scelta selezionata di nuove sementi sono state enormemente ridotte le biodiversità agricole nel mondo. E l’uso indiscriminato di pesticidi (sostanze chimiche utilizzate per combattere gli organismi viventi dannosi alle coltivazioni) ha prodotto un degrado ambientale ed ha arrecato problemi di contaminazione chimica, minacciando la salute pubblica e l’ecosistema. La Rivoluzione Verde, quindi, ci insegna che per risolvere la questione della fame nel mondo non è sufficiente aumentare semplicemente la produttività agricola, soprattutto se questa non è una produzione agro-alimentare sostenibile, cioè una produzione che non solo aumenti la redditività e la competitività del settore agricolo dei paesi in via di sviluppo, ma migliori anche le condizioni di vita delle popolazioni che abitano le zone rurali coinvolte, promuovendo buone pratiche ambientali e creazione di servizi per la conservazione degli habitat, della biodiversità e del paesaggio.
Per eliminare la fame nel mondo occorrerebbe ripensare il modo di produzione agricolo di tutto il Terzo Mondo, visto che la produzione di cibo delle grandi major dell’agribusiness globale viene indirizzata ai gusti ed alle necessità dei mercati ricchi del Primo Mondo.
La liberalizzazione agricola operata dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) a metà degli anni ’90 ha causato una modifica enorme del mercato alimentare globale; infatti, le terre dei Paesi terzi, meno sfruttate di quelle dei Primo e Secondo Mondo, sono state utilizzate per prodotti da export adatti ai mercati Occidentali; mentre le terre per produrre alimenti adatti alle popolazioni locali sono state riprogrammate progressivamente per questo nuovo sistema del global food market.
La produzione di cibo nei Paesi terzi sulla base delle pressioni dell’agribusiness globale porterà probabilmente ad un disastro ambientale che conosceremo presto.
All’agribusiness periferico viene applicato lo stesso modello “mordi e fuggi” che ha caratterizzato la delocalizzazione delle aziende produttive non-food: salari al ribasso, eliminazione del welfare, contrazione del mercato interno.
La crisi alimentare che colpisce le aree dove l’Occidente ha delocalizzato gran parte delle sue prime e seconde lavorazioni, in virtù del basso costo della manodopera, produrrà un’altra vittima della crisi della catena alimentare: il Primo Mondo.
Non è da sottovalutare anche un altro fenomeno che si sta già verificando: la necessità di espandere il mercato non alimentare dei Paesi del Terzo Mondo per assorbire la sovraproduzione dell’Occidente avrà come effetto non solo che diminuirà la disponibilità delle masse locali a lavorare a salari bassi, ma anche che diminuirà la superficie e la produttività dei terreni disponibili.
Di fronte a questo paradosso economico e sociale occorre senza dubbio pensare ad un altro modello di sviluppo, che preveda anche di essere disponibili a scontare un maggior prezzo medio dei fattori della produzione nel Terzo Mondo, pur di evitare una crisi irrecuperabile dovuta, come si è visto, all’elevata crescita demografica, alla distruzione dell’habitat agricolo, al depotenziamento della forza lavoro locale.
Possiamo individuare 3 criticità nelle nuove direzioni che ha intrapreso l’economia globale:
1) la necessità di fornire cibo sia alle periferie del mondo (in forte crescita demografica ed economica), che al Primo Mondo (che non potrà più mantenere i costi della sua agricoltura protetta);
2) il mix di protezionismo e di deindustrializzazione che ha colpito da tempo le economie mature;
3) l’impossibilità di sostenere il mercato alimentare dei Paesi del Terzo Mondo a spese dei ricchi consumatori finali dei loro prodotti selezionati (es. ananas e banane di un solo tipo; gamberetti in aree di pesca protette; etc.)
Altra criticità importante per la sicurezza alimentare è che il boom economico di alcuni BRIC’S, primo tra tutti il Brasile, si è sviluppato per gran parte con l’incentivazione, anche fiscale, del carburante organico.
Il combustibile derivato dall’agricoltura, la cui produzione è sostenuta ed incentivata dai sussidi:
- sta causando la diminuzione delle aree destinate alla produzione di cibo;
- è il legame tra il mercato dei petroli Opec e non Opec e quello dell’agrifuel, provocando un aumento dei prezzi già sussidiati del petrolio vegetale;
- è l’inizio, su questa base, di una speculazione sui future agricoli ed alimentari che sconta l’aumento dei prezzi e concorre alla finanziarizzazione malata dell’economia globale.
Le recenti crisi alimentari del 2008 e del 2012 sono state causate dalle forti speculazioni dei mercati finanziari sui prodotti agricoli: quando il mercato petrolifero e quello della speculazione non alimentare sono di scarsa redditività, i capitali si rivolgono ai titoli del mercato agricolo, determinando un aumento dei prezzi che è puramente finanziario e non influenza in alcun modo l’accumulazione di capitale agricolo. Secondo alcuni economisti , lo scoppio della bolla dei prezzi agricoli è determinato unicamente dalla speculazione finanziaria e dalla massiccia conversione all’etanolo di molti terreni, soprattutto nei paesi del Terzo mondo.
Nei paesi del Primo Mondo il costo del cibo assorbe solo il 20-25% della spesa mensile delle famiglie; mentre nel Terzo Mondo assorbe il 60-70% del loro reddito mensile.
Secondo uno studio della FAO, un aumento del 10% del prezzo dei cereali sul mercato comporta per i Paesi importatori netti di cibo, in particolare quelli del Terzo Mondo, un costo aggiuntivo di 4,5 miliardi di USD.
In questo modo, un Paese finanziariamente debole non può permettersi nessun altra spesa se non quella per la sopravvivenza, ed una quota sempre maggiore di poveri resta esclusa dalla distribuzione del cibo.
Occorre pensare il nuovo: col grano o con la soia non può funzionare quel che vale per i titoli bancari o per i pezzi di ricambio delle auto.
L’aumento record dei consumi è dovuto alla crescita della popolazione, all’aumento della ricchezza ed alla conversione degli alimenti in combustibile per auto.
Se non si riuscirà ad invertire queste tendenze i prezzi del cibo continueranno a salire, portando il nostro sistema al collasso, in una lotta di potere globale per la sicurezza alimentare.
Sul piano economico, stabilire il prezzo del cibo, un bene così necessario alla sopravvivenza, è paradossale: al cibo non si può rinunciare, e ciò ha dato luogo ad un mercato oggi determinato dal prezzo dei petroli, che influisce sul costo dei fertilizzanti, su quello del trasporto, e sul meccanismo che spinge il mercato a favorire il passaggio dei terreni dalla produzione alimentare a quella del biocombustibile. Ogni anno viene perso circa 1/3 delle superfici arabili e produttive senza che, per la velocità del processo, sia possibile la ricostituzione delle superfici fertili.
Negli USA, una delle principali agricolture del pianeta, i sussidi per la produzione di etanolo ricavato dalle granaglie hanno comportato che circa 1/3 del grano prodotto sia utilizzato per gli idrocarburi, con l’effetto di far rialzare di molto il prezzo delle granaglie destinate all’alimentazione.
La combinazione di carenza idrica – che nei paesi del Medio Oriente è strutturale – di crisi di produttività dei suoli e di aumento dei costi dei fertilizzanti farà sì che, entro il 2015, alcuni paesi, anche se ricchi (come l’Arabia Saudita), saranno totalmente dipendenti dalle importazioni per soddisfare le necessità nutrizionali primarie delle loro popolazioni, con rilevanti conseguenze politiche e strategiche .
Secondo la Banca Mondiale, circa 150 milioni di persone in Cina e circa 180 milioni in India sono nutrite con granaglie irrigate da acquedotti che si stanno disseccando. La combinazione di crisi idrica ed alimentare coinvolgerà un numero rilevante di persone arrivando a lambire anche le economie agricole dell’UE.
Non trascurabile è il problema delle malattie del grano: negli ultimi anni, sono state identificate 7 nuove malattie come causa di distruzioni bibliche dei raccolti, che si aggiungono a quelle provocate da locuste ed insetti vari, oltre che dai disastri naturali. Questa situazione spinge verso l’alto il prezzo dei beni alimentari primari ed implica grossi investimenti che solo l’agribusiness può permettersi e, al contempo, mette fuori mercato i produttori piccoli e medi, mettendo in crisi le classi povere e quelle medie. La disponibilità dei fertilizzanti fosforici, secondo una ricerca della Global Phosphorus Research Initiative, sarà esaurita entro i prossimi 30-40 anni, il che sta incidendo sul continuo aumento dei loro prezzi.
Uno studio della Banca Mondiale del 2011 ha calcolato un aumento globale dei prezzi alimentari del 36% medio annuo.
A far salire i prezzi alimentari concorrono diversi fattori:
- la diversione verso i biocombustibili, che fa salire il costo medio del cibo di base;
- l’aumento del costo dei fertilizzanti e del costo dei componenti della produzione agricola, che colpisce di più i paesi del Terzo Mondo rispetto agli altri, dove l’agricoltura è protetta e più rappresentata politicamente;
- la diminuzione della produttività, dovuta al progressivo impoverimento dei suoli;
- la scarsità di investimenti nella produttività dei terreni, visto che siamo ancora ossessionati da un’economia del superfluo che distruggerà la nostra capacità di produrre il necessario;
- l’effetto negativo del riscaldamento globale e del cambiamento climatico.
Abbiamo visto che la spinta verso l’alto dei prezzi del cibo è soprattutto dovuta al costo dei petroli ed al suo collegamento col prezzo alternativo dell’etanolo. Per contenerla bisognerebbe non tanto modificare il prezzo del petrolio ma riuscire a controllare la sua imprevedibilità nel breve periodo, che è il motivo della speculazione sul prezzo del cibo. Riducendo la volatilità dei mercati si potrebbe anche gestire meglio il prezzo dei prodotti agricoli.
Si è modificata anche la struttura di distribuzione del cibo: con la massificazione e l’allungamento della catena distributiva del cibo destinato al mercato globale (il c.d. global food) le grandi catene di vendita al dettaglio alimentare, fanno il prezzo e pagano il meno possibile la materia prima, a danno dei piccoli e medi produttori sui quali scaricano tutta la volatilità dei prezzi.
Sarebbero ipotizzabili diverse contromisure per uscire da questa difficile situazione:
- non fare entrare nel mercato finanziario operatori non appartenenti alla catena del cibo;
- obbligare i paesi più deboli dal punto di vista finanziario ed alimentare a costituire riserve strategiche, che siano, poi, controllate da Enti internazionali terzi.
Nell’UE, secondo l’Eurostat, ci sono 7.300.000 aziende agricole, ed ulteriori 6.400.000 con dimensioni inferiori alla c.d. Unità di Dimensione Economica (ESU= European Size Unit). Gran parte delle aziende che vivono allo stato di sussistenza si trova in Romania, Polonia ed Italia. Nel settore agricolo ed alimentare primario della UE lavorano 11.700.000 cittadini. Le aziende attive in Italia sono 1.680.000 ma il numero è in costante diminuzione.
Si tratta di un’agricoltura sussidiata, che viene sostenuta economicamente per il raggiungimento di alcuni obiettivi dell’UE quali:
- la sicurezza alimentare che eviti l’apertura senza protezioni all’agribusiness ed all’industria globale del cibo, con ripercussioni sulla crisi occupazionale del settore e sulla salute dei consumatori;
- la garanzia di una base politica stabile.
La diffusione delle industrie alimentari in Europa non è omogenea rispetto a quella delle aziende agricole: la Francia è il paese a maggiore densità d’imprese di food & beverage processing (1/5 di tutto il settore nell’UE), seguita da Italia, Germania e Polonia. Nel sistema del cibo l’UE tende a favorire prodotti ad alto costo unitario, elevata qualità, mercato determinato e interno (comunitario); al contrario, negli USA la catena del cibo tende a favorire il business intermedio ed a rendere ottimali gli investimenti nello stoccaggio e nel trasporto.
Il comparto della distribuzione ed elaborazione del cibo occupa, nell’UE, ben 6.600.000 addetti, producendo un valore aggiunto di 188 miliardi di Euro per il sistema industriale. Il c.d. “field to fork” (dal campo alla tavola) è un’industria di trasformazione, fortemente legata alle importazioni di materiali primari, che ha un’alta produttività media ed ottimizza – superandoli – i costi della protezione dei prodotti agricoli UE. Le imprese agricole dell’UE sono 310.000, occupano 4.700.000 addetti ed hanno una capacità di generare surplus per 850 miliardi di Euro.
L’export di cibo di alta qualità dall’UE verso i BRIC’S tende ad essere un valore anelastico (la domanda non cambia molto al variare del prezzo), dato che la crescita dei potenziali consumatori locali non è tale da accendere il mercato: si tratta, quindi, di evitare il rischio di un export debole verso aree che, invece, rendono l’UE importatrice netta di materie alimentari ad alto e crescente costo, come il cacao, il tè, il caffè, come pure di evitare il rischio di un’impennata dei prezzi del grano americano e canadese dovuta anche ad una siccità crescente.
La speculazione sui prodotti agroalimentari in ambito europeo fa uscire capitali necessari all’aggiornamento tecnologico e produttivo e li dirige verso la rendita; che è esterna al mercato dell’agroalimentare e, in particolare, allo stesso mercato finanziario europeo. Questo perché l’UE, sul piano delle decisioni finanziarie ed economiche, non ha le strutture organizzative per evitare operazioni speculative sulle commodity dell’alimentare, che, solo nel 2008, hanno generato rendimenti per oltre 204 miliardi di Euro .
Si tenga presente che il comparto del food & beverage è il più importante dell’industria manifatturiera dell’UE a 27, con una quota di export che nel 2010 è stata pari a 63,10 miliardi di Euro, ed una presenza di piccole e medie imprese per oltre il 90% ; che sono, poi, le più deboli e meno adatte a gestire attacchi finanziari sui mercati esteri (attacchi che possono riguardare l’immagine, i marchi, le barriere non tariffarie etc.).
La UE è il principale esportatore di cibi e bevande al mondo, ma le sue quote di mercato sono progressivamente in calo: si va dal 20,1% registrato nel 2000, al 17,8% nel 2010: questo perché l’UE sconta la propria scelta politica e culturale di non declinare in termini di mercato di massa quei prodotti che non hanno eguali in mercati di nicchia e in condizioni di protezione del marchio e di sostegno ai prezzi.
Negli USA è molto diverso: lì operano le forze che fanno aumentare i prezzi dell’alimentare, come i prezzi elevati dei petroli, l’aumento dei salari e dei redditi nei Paesi emergenti, il riscaldamento globale, la modifica delle dinamiche nelle aree di produzione agricola e di allevamento. Tutti fenomeni che legano l’economia del cibo negli USA a quella nell’UE.
La rete dell’economia del cibo negli USA è fatta da marche private che hanno bisogno, per la propria sopravvivenza d’impresa, di abbassare rapidamente i costi di produzione e di adattarsi a mercati ormai frazionati. Dal 2008 ad oggi i prezzi al dettaglio sono aumentati ogni anno del 2-3%, con una tendenza alla polarizzazione delle imprese: da un lato le grandi aziende dell’alimentare che riescono a gestire le tendenze avverse dei mercati; dall’altro le piccole aziende che possono soltanto ricorrere al retail (=vendita al dettaglio) di marchi globali. Questo perché il marchio globale paga il meno possibile la materia prima, e guadagna sul rapporto tra lavorazione ed abbattimento dei costi di produzione.
Crea, così, il mercato che desidera: un proletariato globale che mangia male e, in proporzione, paga molto il proprio cibo. Un cibo che sarà di basso livello nutritivo ma molto reclamizzato (si stima che la pubblicità comporti un ricarico di almeno il 13% sul prezzo finale).
Negli USA, nel 2011, è stato venduto cibo confezionato per 331,86 miliardi di USD: di questo, il 21% è costituito da prodotti da forno; il 16% da latticini; il 10% da cibo congelato; un ulteriore 10% da dolci e snack.
Questi ultimi hanno registrato un aumento delle vendite, sempre nel 2011, del 6,6%. Il cibo fresco, quello delle uova, della frutta e della verdura, negli USA è un mercato stagnante, sebbene valga 77,5 milioni di tonnellate di derrate: si tratta di cibi o troppo cari per il consumatore medio; oppure poco pratici per nuove categorie di consumatori che si affermano a seguito del cambiamento delle abitudini di vita (si pensi ai single, alle donne che lavorano e curano la casa, al nomadismo lavorativo che induce al consumo di cibi precotti e confezionati).
Il nesso tra grandi catene di vendita del cibo e retail negli USA è essenziale; mentre nell’UE crea contrasti.
La UE ha modulato la propria economia del cibo posizionandosi in una dimensione che va dalla sussistenza alla produzione per le fasce medio-alte dei mercati globali, privilegiando la protezione del proprio mercato interno all’espansione del suo potenziale export di massa.
Gli USA proteggono il loro mercato-base delle granaglie, gestiscono una catena del valore imbattibile sui prezzi per il proprio mercato interno di massa, gestiscono una rete distributiva che esclude, di fatto, tra retail e grandi catene, ogni concorrenza.
Anche nella Federazione Russa la questione del cibo è molto diversa dagli USA. Mosca importa in media circa il 40% del proprio fabbisogno nutritivo dall’estero; oltre il 50% delle carni e dei latticini, soprattutto nelle grandi città . I grandi magazzini detengono una quota di mercato del 50%, le piccole reti di retail circa il 35%, i negozi di nicchia il 20,5%: una distribuzione frazionata segno del frazionamento della società e dell’economia russa. Le grandi reti di distribuzione internazionali del food & beverage si sono tutte ritirate dal mercato russo, a parte la tedesca METRO AG, a causa del controllo di buona parte del mercato finale da parte delle organizzazioni criminali: la rete dell’alimentare è ideale per il riciclaggio perché tutti mangiano e bevono (mentre non tutti, per fortuna, consumano droghe!). La necessità di denaro cash nella catena distributiva, poi, completa il quadro.
Le sfide per la Federazione Russa saranno:
- di rimettere in attività le grandi fattorie comuni dell’epoca sovietica, migliorandone produttività ed efficienza economica;
- di riproporre una piccola proprietà contadina che si svincoli dalla semplice autosufficienza alimentare (diversamente da ciò che accade nell’UE);
- di evitare di distribuire aiuti diretti ai produttori per i quali sembra non ci siano disponibilità finanziarie rilevanti.
In Cina la questione alimentare è stata affrontata negli ultimi anni attraverso un “socialismo con caratteristiche cinesi”. Vista la grande capacità di risparmio delle famiglie cinesi, il consumo di cibo del cinese medio è aumentato nel 2012 del 12,5%, con previsioni di rialzo di un ulteriore 10%. Il consumo di bevande alcoliche è cresciuto dell’8,9%, di cui i soft drink – simbolo dell’occidentalizzazione di massa del Paese di Mezzo – hanno aumentato le vendite del 10%. Le vendite di alimentari al dettaglio sono aumentate del 12%. Le prospettive, però, non sono rosee come i numeri appena letti farebbero pensare: infatti, lo sviluppo economico urbano delle aree a maggiore industrializzazione è avvenuto a scapito del terreno ad uso agricolo. Il problema è che alla diminuzione dei suoli agricoli non è corrisposto un aumento della produttività media in agricoltura, per cui ci sarà un punto di non ritorno, raggiunto il quale Pechino dovrà:
- importare più cibo, soprattutto prodotti base, con ripercussioni sulla sua bilancia dei pagamenti;
oppure
- far diminuire la propensione al consumo delle masse urbane e far diminuire il limite di sopravvivenza alimentare di quelle agricole, altrimenti parte dei risparmi delle famiglie deve essere utilizzato per la nutrizione, con effetti depressivi sull’economia.
Il mercato interno dei latticini è coperto per il 70% da sole 5 imprese; mentre circa 1.200 aziende produttrici sono state chiuse a seguito di diversi scandali: si è verificata, quindi, una verticalizzazione del sistema alimentare che ne permette un maggiore controllo politico.
Al contrario di quanto accade in Occidente, poi, Pechino sta finanziando massicciamente la ricerca scientifica sull’agroalimentare, soprattutto sugli OGM, che saranno l’asse produttivo della Cina futura. L’interesse cinese per l’abbattimento dei costi di produzione e per l’incremento della produttività media è massimo; quasi inesistente, invece, quello per la protezione della salute.
Il settore della piccola distribuzione in Cina vale 707,2 miliardi di USD, con una crescita annua del 7%. Il settore della ristorazione vale 366 miliardi di USD, con tasso di crescita del 7,6% annuo. Il mercato del processed food – il cibo trattato – vale 140,4 miliardi di USD, con un tasso di crescita del 13,3% che è indice dell’occidentalizzazione dei consumi e della società cinese. La Cina, inoltre, è il 1° produttore e consumatore al mondo di pesce, con una quota del 35% del prodotto globale. L’acquacoltura è diffusissima anche se è stata verticalizzata, ed ora è gestita da pochi e grandi produttori. Nel complesso, quindi, la linea seguita dalla Cina è la stessa di Mao: l’autosufficienza alimentare; che, oggi, il Paese ha raggiunto al 98% .
Ancora diversa, dal punto di vista geoeconomico, è la situazione dell’India: la crescita del PIL al 7,3% annuo non ha generato un aumento sensibile di potere d’acquisto nel settore alimentare che c’è stato in Cina, con effetti caotici nel rapporto tra città e campagne.
Nel 2011 il consumo di cibi e bevande è stato per circa 367 miliardi di USD. Per questioni religiose, il 70% del cibo trattato e confezionato riguarda i latticini e vale un giro d’affari da 25,4 miliardi di USD nel 2011. L’acquacoltura è scarsamente diffusa ed è gestita da una rete di produttori piccoli e medi (come in UE). La carne, sempre per motivi religiosi, non può essere importata e da ciò deriva che molti settori della popolazione versino in gravi condizioni alimentari. La distribuzione della carne è scarsamente legata alle grandi catene, il che comporta l’aumento dei costi d’intermediazione e di trasporto che rendono i prezzi rigidi. La fame resta in molte aree del Paese: nell’India rurale 1 bimbo su 3 è malnutrito; dal 1997 al 2013 sono stati registrati circa 200.000 suicidi di contadini , che accumulano debiti e finiscono in mano agli usurai che immettono denaro fresco nelle casse della malavita cittadina.
Il Sistema della Distribuzione Pubblica del Cibo (Public Distribution System) in India ha continuato, quindi, a mantenere le sue caratteristiche di mercato nazionale protetto, anche se c’era sempre meno da proteggere, visto che gran parte del cibo da distribuire doveva essere comprato all’estero a caro prezzo; il che andava a sommarsi ad una rete di sussidi – anche per il carburante – sempre meno disponibili data la fase di crisi finanziaria globale.
Cosa fare, dunque?
Occorre senz’altro rivedere i criteri di liberalizzazione degli scambi alimentari ed agricoli nel mondo (l’unico criterio non può continuare ad essere la semplice valutazione dei prezzi ottimali); e non si deve abbandonare la politica protezionistica adottata da UE e Cina, anche in presenza di alti tassi di importazione.
Si potrebbe pensare, in linea teorica, ad una serie di iniziative, come ad esempio:
- escludere dal commercio globale, calcolandolo annualmente, delle quote di prodotto alimentare da prezzare in modo diverso;
- promuovere una nuova cultura alimentare anche in Occidente, come già sta facendo la Cina, che non privilegi più i prodotti esotici provenienti dai campi e dalle imprese alimentari del Terzo Mondo;
- formare il proletariato urbano per utilizzarlo nelle aree agricole (il che abbasserebbe la disoccupazione nelle città e farebbe diminuire il costo della mano d’opera);
- interrompere gli aiuti di Stato al biocombustibile, riconvertendo i finanziamenti verso progetti agricoli ecosostenibili che favoriscano la piccola e media proprietà.
La volatilità dei prezzi, cioè la loro rapida variazione nel tempo e nello spazio, aumenta i rischi d’insolvenza degli operatori. Nel caso del cibo, la volatilità dei prezzi è una minaccia anche per la sicurezza alimentare. Tale volatilità, dal 2000 in poi, è stata molto più alta che nei 20 anni precedenti; pur tenendo conto che il mercato agricolo e quello delle carni sono di per sé imprevedibili, sia per la stagionalità che per il clima, gli eventi atmosferici, le politiche.
Tra le cause dell’aumento unitario di tutte le tipologie di commodity alimentari e della maggiore volatilità dei prezzi del cibo a livello mondiale vanno senz’altro citate:
- l’aumento della popolazione;
- l’aumento dei redditi medi di alcuni Paesi, la c.d. global middle class;
- la creazione del mercato protetto e sussidiato dei biocombustibili;
- il sempre maggiore collegamento strutturale tra mercato petrolifero e trading alimentare. I prezzi dei petroli e dei loro derivati influenzano direttamente il costo di produzione del cibo a causa dei carburanti e dei fertilizzanti, ma anche perché molti investimenti nel settore alimentare si muovono tra le transazioni con un indice di redditività calcolato sul modello dei prodotti finanziari, in cui il prezzo del petrolio e del gas naturale è sempre determinante;
- l’incertezza, da parte degli operatori più esperti del mercato-mondo, nel valutare la dimensione degli stock di prodotto; valutazione che deve essere fatta tenendo conto del clima e della variabilità geografica dei prodotti, non sempre tenuti nella debita considerazione. Ad aiutare l’incertezza dei prezzi e la speculazione c’è anche la dimensione sempre più piccola di alcuni stock di generi alimentari primari sul mercato-mondo.
L’aumento dei prezzi, però, ha ripercussioni gravi: infatti, se nei Paesi del Primo Mondo il cibo vale il 20% della spesa mensile delle famiglie, in quelli del Terzo la spesa per il cibo assorbe oltre il 40% del reddito mensile.
Il mercato del cibo è stato quello che per primo ha fatto uso dei derivati finanziari; ma il meccanismo ha dato luogo alla polarizzazione dei valori di mercato: più aumenta la volatilità e l’uso dei contratti derivati, più aumenta il prezzo finale al dettaglio dei beni e diminuisce il rendimento netto dei produttori di cibo (finanche a diventare negativo). I rendimenti negativi alla fonte (cioè per i produttori) portano a 2 conseguenze: o si chiedono sostegni allo Stato; o si innescano politiche protezionistiche. Entrambe comportano l’aumento della volatilità dei prezzi.
Il problema, oggi, non può più risolversi con azioni di Governo come quella di porre una limitazione legale alle transazioni; il “mercato nascosto” dei titoli a termine può aggirare facilmente ogni limitazione legale delle transazioni e la tecnica dell’over the counter – la transazione bilaterale diretta tra operatori – lascerebbe campo libero alle speculazioni sui titoli a termine alimentari.
Il mercato dei derivati sui prodotti alimentari e non muove ogni giorno 800 trilioni di USD e sarebbe impossibile controllare tutta questa massa di contratti. Il Dodd-Frank Act, la legge che regola le attività di Wall Street dopo la crisi dei subprime, stabilisce che si possa tenere al massimo il 25% del capitale in contratti a termine sui prodotti alimentari di base. Ma la quota del 25% stabilita è quasi del tutto speculativa: infatti, soltanto il 2% dei contratti a termine si conclude con la cessione fisica del bene sottostante al future.
I fondi guadagnano comunque perché, tenendo i contratti a lungo o comprandone in grande quantità, hanno creato un mercato del compratore dei titoli derivati alimentari che è indipendente dalle dimensioni degli stock alimentari o dalle eventuali crisi climatologiche locali.
Il volume degli investimenti speculativi nel settore, dopo la deregulation post Reaganiana del 2000, con l’introduzione di prodotti finanziari dedicati, prima da parte della Goldman Sachs e poi da altre Banche d’affari globali, è passato da 1,5 miliardi di USD nel 1995 ad oltre 300 miliardi di USD del 2011 .
Se proibire serve a poco, allora cosa fare?
Alcune possibili azioni sono:
- aumentare la sicurezza alimentare, per limitare le posizioni “lunghe” degli speculatori;
- diminuire la pressione della domanda proveniente dai Paesi del Primo Mondo che tendono a fare e ad aumentare il prezzo unitario dei prodotti alimentari;
- organizzare un’informazione immediata ed on line delle scorte, per scoraggiare le operazioni a breve o a lungo termine di carattere eminentemente speculativo, che si basano su un’informazione ristretta e limitata dei mercati e dei compratori, la cui unica informazione reale è spesso l’imitazione del comportamento degli altri operatori (il c.d. “effetto gregge”).
I produttori di cibo orientato alla speculazione hanno tutto l’interesse a favorire le grandi monocolture che, però:
- inficiano la biodiversità;
- sono l’attività agricola e di allevamento più dannosa ed invasiva dal punto di vista ecologico;
- creano l’illusione della scarsità;
- favoriscono il passaggio dei terreni al biofuel.
Quali sono le soluzioni per limitare la crescita automatica della speculazione sui future alimentari o delle commodity?
Per esempio:
- evitare i contratti a lungo termine, che nel settore alimentare non hanno senso;
- favorire i mercati locali e quelli “spot”, dove sia gli strumenti finanziari che i beni sottostanti sono trattati per la loro immediata soluzione, proibendo l’over the counter;
- estendere a tutto il Primo Mondo, dopo che è stata proposta in Gran Bretagna, la Robin Hood Tax: un mix di tassa sulle transazioni finanziarie, tassa sulle attività finanziarie ed oneri vari a carico delle Banche attive nel settore.
Secondo un recente studio della Banca Mondiale l’aumento dei prezzi alimentari – del 130% dal 2002 al 2008 – è dovuto per il 25-30% all’aumento del costo del carburante, e, quindi, dei fertilizzanti derivati da idrocarburi, e per il 70-75% dal biocombustibile. Secondo la FAO, nel periodo dal 1967 al 2007 c’è stata un’espansione dei terreni arabili del 115%; mentre dal 2008 ad oggi la terra disponibile per l’agricoltura è aumentata soltanto dell’8%. Dal lato del consumatore, invece, si prevede che:
- il consumo di carne salirà dai 32 Kg annuali pro capite di oggi, ai 52 Kg nel 2035;
- il consumo di pesce avrà un incremento del +45% annuo pro capite.
Alla crescita dei consumi ed al quasi raddoppio dell’allevamento fa da paradossale contraltare la riduzione inevitabile del terreno arabile, prima vittima in quanto primo fornitore di materiale essenziale per l’allevamento degli animali. Questi dati sono una spinta ulteriore alla speculazione: in un contesto di mercato in espansione lo stock disponibile dei beni non può che diminuire, e questa è la condizione primaria per ogni operazione finanziaria a termine di successo.
Fino al 2030 anche la richiesta di energia aumenterà, del 45%, il che aumenterà la volatilità delle transazioni petrolifere che si porteranno dietro gran parte dei future alimentari. La pesca è fortemente dipendente dal prezzo dei carburanti sia per ciò che riguarda i costi che per i rendimenti: un altro brokeraggio a favore della speculazione sui titoli dell’alimentare.
Ci stiamo preparando a situazioni molto simili a quelle che causarono la crisi alimentare nel 2007-2008: quando l’ascesa della speculazione sui titoli alimentari fece aumentare i prezzi del cibo dell’83% in un triennio (2005-2008) e crescere la popolazione mondiale in condizioni di fame del 12% portandola a 963 milioni di persone.
Mentre India e Cina sono quasi del tutto autosufficienti nella produzione di carni alimentari, il problema riguarda la produzione industriale di carni nel Primo Mondo che, oggi, interessa circa il 40% del totale ed è finanziata dai Governi e dagli interventi degli enti finanziari internazionali, e che comporta anche un processo d’integrazione verticale dei produttori che ha raggiunto un tasso particolarmente elevato.
Negli USA l’83,4% di tutto il mercato delle carni bovine è nelle mani di 4 produttori; e 5 aziende controllano il 48% dell’intera linea del retail alimentare (dato del 2009). La carne di maiale è lavorata da 3 sole aziende che coprono il 66% del prodotto totale. Soltanto 3 multinazionali controllano il 90% del mercato mondiale delle granaglie. Il mercato del cibo è di fatto un oligopolio in cui un cartello di produttori specializzati in un segmento vi esercita un monopolio di fatto. L’esclusione dei piccoli e medi produttori dal mercato ha fatto sì che esso non fosse permeabile alla formazione dei prezzi reali, ed invece fosse prono a sostituire i costi effettivi con le remunerazioni dei fattori di produzione, generate dai calcoli delle grandi imprese.
Nell’UE la concentrazione produttiva nel settore alimentare è meno diffusa di quanto non lo sia negli USA.
I motivi sono rinvenibili nel maggior potere delle associazioni dei produttori che hanno un forte peso politico; nel maggior peso dei sussidi comunitari e nazionali che, col sistema dei pagamenti diretti, possono adattare rapidamente l’offerta alimentare alle dimensioni ed alle trasformazioni del mercato; nella diversa configurazione della domanda di cibo, più variegata, più attenta alla qualità degli alimenti, ai loro effetti sulla salute del consumatore.
I costi reali sono maggiori rispetto al sistema statunitense perché il meccanismo dei sussidi e degli aiuti diretti fa aumentare i costi fiscali di finanziamento della Politica Agricola Comunitaria, e non libera il mercato dell’UE dagli effetti dell’aumento speculativo dei prezzi dei prodotti-base, che è nelle mani di entità del tutto esterne alla finanza ed alla politica comunitaria.
Cosa si può fare?
Ad esempio:
- eliminare progressivamente i biocarburanti, che, secondo il Fondo Mondiale, causano l’aumento del 70% dei prezzi del granturco e del 40% di quelli della soia;
- controllare la vendita degli OGM da parte delle multinazionali ai farmers, poiché essi non aumentano la produttività media dei suoli ma sono solo adatti alle grandi produzioni intensive;
- cambiare le normative che riguardano le multinazionali del cibo, modificando le quote internazionali ed aumentando i controlli;
- evitare la progressiva ulteriore liberalizzazione semplice del sistema alimentare.
Si potrebbe anche prevedere un’Autorità specifica sanzionatoria a livello globale, magari in collaborazione con la FAO.
Come pure si potrebbe procedere alla stipulazione di un Accordo con Cina e Russia, paesi in cui il mercato finanziario dell’alimentare è in grande sviluppo: Accordo sulla base del quale loro potrebbero dare una quota del proprio surplus alimentare, quando c’è, a prezzi di mercato, e noi potremmo permettere loro di entrare, pro quota, nel mercato finanziario dei future del cibo alle condizioni stabilite dalla nuova Autorità Globale di cui anche loro farebbero parte.
Sarebbe auspicabile anche creare dei mercati regionali per i produttori locali, con prezzi stabiliti dal “vecchio” liberalismo della domanda e dell’offerta reali.
La tendenza alla concentrazione delle imprese andrà avanti ancora per molto tempo: fino al 2009 ci sono state 283 fusioni ed acquisizioni. Negli USA la DuPont, insieme a Monsanto e Pioneer, controlla il 58% del mercato delle sementi di grano, OGM e non OGM. La Monsanto da sola controlla il 70% del grano transgenico, il 90% della soia OGM, il 90% dei semi del cotone OGM. Soltanto 3 società, la Archer Daniels, la Midland e la Bunge & Cargill, controllano il 90% del mercato dei grani nel mondo. Soltanto 3 società, la JBS, la Cargill e la Tyson, gestiscono la lavorazione ed il confezionamento delle carni. E’ facile immaginare il potere di pressione e di gestione dei mercati che questi monopolisti possono esercitare sui governi e sulle organizzazioni internazionali deputati a trattare le questioni dell’agricoltura e del cibo.
In Europa il 99% delle imprese del settore del cibo e bevande è di piccola e media dimensione localizzate per lo più nel Sud Europeo; mentre alcune grandi imprese operano nell’Europa del Nord. I 10 maggiori produttori europei detengono solo il 15% del mercato; ma 2 aziende con sede in Europa sono tra le maggiori al mondo: la Nestlè e la Unilever. Non mancano fenomeni di verticalizzazione delle imprese, che imitano il sistema americano: ad esempio, più del 40% dei dipendenti del settore opera nelle grandi aziende, e solo il 26% nelle piccole e medie imprese. Ma soltanto l’1% delle aziende del settore può essere catalogato come “grande impresa”. La grande quantità di piccole e medie aziende europee riescono a sopravvivere al ciclo del mercato ed al meccanismo di gestione dei gusti e dei comportamenti di massa che i colossi alimentari determinano tramite i mass media, tramite la forte normativizzazione del mercato ed al protezionismo statale che spesso vengono favoriti dalle stesse multinazionali.
La concentrazione della catena del cibo riguarda in Europa soprattutto la grande distribuzione, con Tesco e Carrefour che riescono a fare pressione sui produttori per abbattere i prezzi creando bassi livelli di rendimento sui prodotti di massa che spingono le aziende verso la concentrazione verticale. La tendenza generale invece è quella di una progressiva frammentazione del mercato e di una creazione di mercati di nicchia ad alto rendimento ma di difficile predittività.
Nell’UE, cioè, anche le grandi imprese del cibo mantengono un alto livello di qualità dei prodotti, hanno grande facilità nel gestire la distribuzione (data la dimensione e le infrastrutture dell’UE), generano molto valore per unità di prodotto, ma mantengono – al contrario di ciò che fanno negli USA – una bassa produttività del lavoro, un basso livello di investimenti in Ricerca e Sviluppo, un basso tasso di qualificazione della forza-lavoro.
La concentrazione delle imprese porta alla globalizzazione del cibo, della sua produzione, dei gusti e dei comportamenti alimentari. La globalizzazione del cibo porta verso nutrimenti semplici, molto simbolici perché oggetto di pubblicità martellanti, verso cibi semipronti. Il cibo sano, raro e destinato a fasce di mercato più evolute, costa di più del fast food di strada o del cibo standard offerto dalle catene di hamburger e panini.
Il Primo Mondo quando paga lo fa lentamente, mentre la Cina, il Brasile o gli altri paesi BRIC’S hanno moltissima liquidità che serve a pagare subito un bene primario come il cibo, spesso simbolo per le masse degli ex poveri di un irrinunciabile nuovo status: la Cina sarà nei prossimi anni il maggior mercato per i prodotti alimentari di grande diffusione; il Brasile è già oggi il 5° mercato per il cibo; l’India entro il 2015 sarà il 3° consumatore mondiale per snack e dolciumi. Andremo verso una semplificazione e globalizzazione del cibo, dove la composizione del prodotto sarà la più semplice possibile e l’adattamento inevitabile ai mercati locali sarà determinato da dolcificanti, coloranti, esaltatori di sapidità. In Occidente mangeremo sempre peggio, a prezzi medi più elevati per via di criteri di pagamento meno rapidi rispetto a quelli dei BRIC’S, avremo periodi ciclici di carenza di cibo industriale per la forte concorrenza dei mercati emergenti in espansione. Il mercato di trading del riso è ristretto perché i maggiori paesi produttori assorbono quasi completamente la produzione annuale con la loro domanda interna. Il mais è la produzione agricola più intermediata finanziariamente; dopo seguono il grano e la soia. La soia, però, è destinata solo in parte all’alimentazione, ed è spesso utilizzata per il biofuel. DuPont e Monsanto controllano il 65% del mercato mondiale del mais; il 44% di quello della soia; ed il 91% del mercato delle sementi geneticamente modificate. Negli ultimi 2 anni le 2 imprese hanno acquistato il 65% del mais non OGM prodotto in Brasile. La logica è di costituire l’egemonia in entrambi i mercati, quello OGM e quello naturale, ai
quali vendere prodotti diversi ma in regime di controllo pressoché completo della domanda.
I produttori OGM se la passano apparentemente meglio; mentre quelli ancora legati ai sistemi naturali – ancora la maggioranza – sono indotti nella tentazione OGM nel momento in cui i primi subiscono le condizioni, apparentemente amichevoli, del big business. Le grandi aziende del settore food & beverage operano sull’economizzazione della materia prima, che è e deve essere certa. Normalmente, dato che si tratta di fatto di monopolisti, sono le grandi multinazionali a fare il prezzo; ed anche il tipo di pagamento lo fa l’acquirente: ed è sempre la condizione meno agevole per il creditore, che deve accettare ritardi, pagamenti in titoli, saldi che tardano a venire.
Il sistema delle grandi multinazionali del cibo – c.d. Big Food – sul piano sanitario è un costo, non certo una risorsa: interpolando i dati attuali della diffusione dell’obesità (generata dalla tecniche pubblicitarie), il moltiplicarsi delle malattie correlate al diabete, la diffusione delle allergie alimentari e delle malattie autoimmuni dipendenti dall’alimentazione, possiamo calcolare una media globale di costi sanitari indotti dalle politiche di Big food che va induttivamente dai 250 ai 456 miliardi di USD. Dal 1995 ad oggi nel mondo ci sono 65 milioni di persone malnutrite in più, con 1 adulto su 5 in grave sovrappeso.
C’è poi il fenomeno del Land grabbing, le acquisizioni di terreni posti in un’area di guerra o di sostegno umanitario, dopo che sono stati confiscati, depopolati delocalizzati rispetto alle risorse primarie. Il fenomeno riguarda soprattutto l’Africa Subsahariana, ma si registra anche altrove nei paesi più poveri, con Governi deboli e dove la corruzione è diffusa. La corsa alla terra è conseguenza di una serie di fattori: l’enorme crescita demografica che sta interessando il pianeta ed il cambiamento in corso dei paradigmi geopolitici che hanno già prodotto la formazione di nuovi poli di potenza da cui è emerso lo sviluppo di una nuova classe media con abitudini alimentari in evoluzione. Sul versante istituzionale e politico, la domanda crescente di terre, ripensate come asset strategico degli interessi vitali di un paese per soddisfare la domanda alimentare (con gli effetti indotti da un consumo crescente di carne) e quella energetica, si è tradotta nel nuovo fenomeno degli acquisti e concessioni internazionali – da parte di imprese e governi – di vasti terreni arabili, il cosiddetto land grabbing, che coinvolge soprattutto i paesi emergenti come acquirenti. Seppure se ne sia cominciato a parlare dal 2008, si mostra già come un fenomeno importante: in particolare, Stati, Cina ed India, oltre ad Arabia Saudita, Qatar e Bahrein, sono tra i maggiori acquirenti di territori dei paesi africani.
Questa corsa alla terra praticata dai grandi gruppi internazionali, oltre a creare dispute con le popolazioni locali che sfociano in gravi crisi sociali, ha prodotto la marginalizzazione dei piccoli produttori in quanto il sistema, così come è congegnato, conferisce solo alle grandi aziende il potere di determinare il mercato.
Il fenomeno del land grabbing è significativo anche in Brasile. Il Paese, che al momento è la 6^ economia ed il 2^ produttore agricolo del mondo, ha in un primo tempo “subito” l’arrivo degli investitori esteri che hanno acquistato i terreni aumentando notevolmente la loro presenza nell’economia locale e generato la crescita esponenziale di capitale internazionale nell’industria agricola brasiliana, che, nel giro di dieci anni – dal 1995 al 2005 – è aumentato dal 16% al 57%. Tale situazione è stata arginata sotto la Presidenza Lula, che, nel 2007, ha varato, nell’agosto del 2010, una nuova legislazione che limita la possibilità di acquisire appezzamenti di terra a compagnie controllate per il 50% (o più) da capitale straniero. Anche in Brasile l’espansione dell’agri-business ha comportato la conversione delle colture tradizionali in coltivazioni di soia, mais, canna da zucchero ed allevamenti intensivi, come pure l’intensificarsi di conflitti per le terre su cui vivono e lavorano popolazioni indigene e comunità locali.
Il Brasile, tuttavia, oltre a subire il fenomeno del land grabbing, negli ultimi anni ha iniziato a praticarlo. A tal fine ha sviluppato una propria politica di acquisizione di terreni agricoli al di fuori dei suoi confini nazionali come, ad esempio, in Paraguay, dove su 31 milioni di ettari di terra arabile (il 29% della quale è destinata alla produzione di soia) è stato concesso il 25% a investitori stranieri, di cui il 15% ai soli brasiliani. La duplicità del ruolo del governo brasiliano ha portato ad un concatenarsi di eventi che hanno interessato diverse regioni del Sud America. In particolare, la crescita della produzione di soia negli anni ’70-’80 è stata responsabile del dislocamento di 2,5 milioni di persone nello stato di Paraná e di 300.000 nel Rio Grande do Sul. Non si tratta di contrapporre la modernizzazione agricola alla difesa della tradizione, ma di assicurare che gli interessi ed i diritti sulla terra degli agricoltori di piccola scala non siano esclusi da interessi di gruppi forti che siglano accordi e contratti con piena valenza legale.
Scorrendo i dati riportati nello studio di Verie Aarts, intitolato “Unravelling the Land Grab: How to protect the livelihoods of the poor?” pubblicato nel 2009 tra 15 ed i 20 milioni di ettari di terra coltivabile sono stati oggetto di transazioni ed accordi negli ultimi due anni e mezzo, e dal 2004 oltre 2,5 milioni di ettari sono stati assegnati ad operatori stranieri in 5 paesi africani (Etiopia, Sudan, Mali, Ghana e Madagascar).
Il Fatto nuovo non è la vendita o concessione di terre in sé, ma l’estensione dei lotti (contratti su superfici superiori ai 100.000 ettari) e la destinazione d’uso (per garantire la sicurezza alimentare ed energetica degli investitori internazionali) che sono rilevanti per la questione della sicurezza alimentare dei paesi poveri, al punto che il Segretario generale della FAO, nonostante la FAO stessa avesse per anni incoraggiato gli investimenti esteri in agricoltura, teme che questa nuova forma d’investimento sia di fatto un tipo di neocolonialismo da parte dei paesi emergenti che hanno seri limiti di terra e acqua ma significative dotazioni di capitale finanziario (si pensi ai paesi del Golfo), di paesi con popolazione numerosa e seri problemi di approvvigionamento alimentare (Cina, Corea del Sud e India), oltre che di Stati Uniti, Giappone, Sudafrica e Libia.
La qualità degli investimenti, come dimostra il fenomeno del land grabbing, non è un aspetto trascurabile; il settore pubblico potrebbe svolgere un ruolo prezioso per incentivare investimenti non nocivi alla sicurezza alimentare.