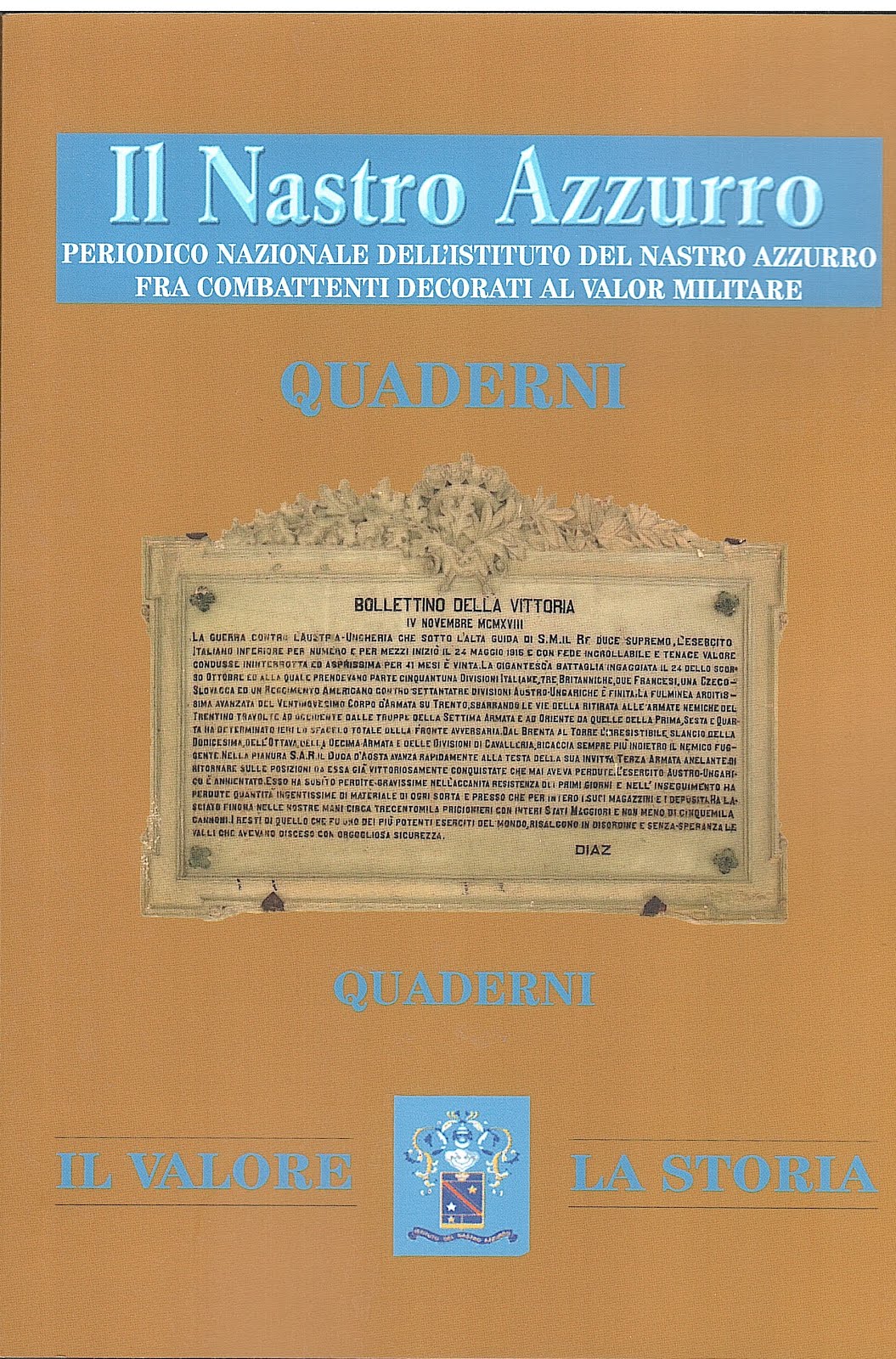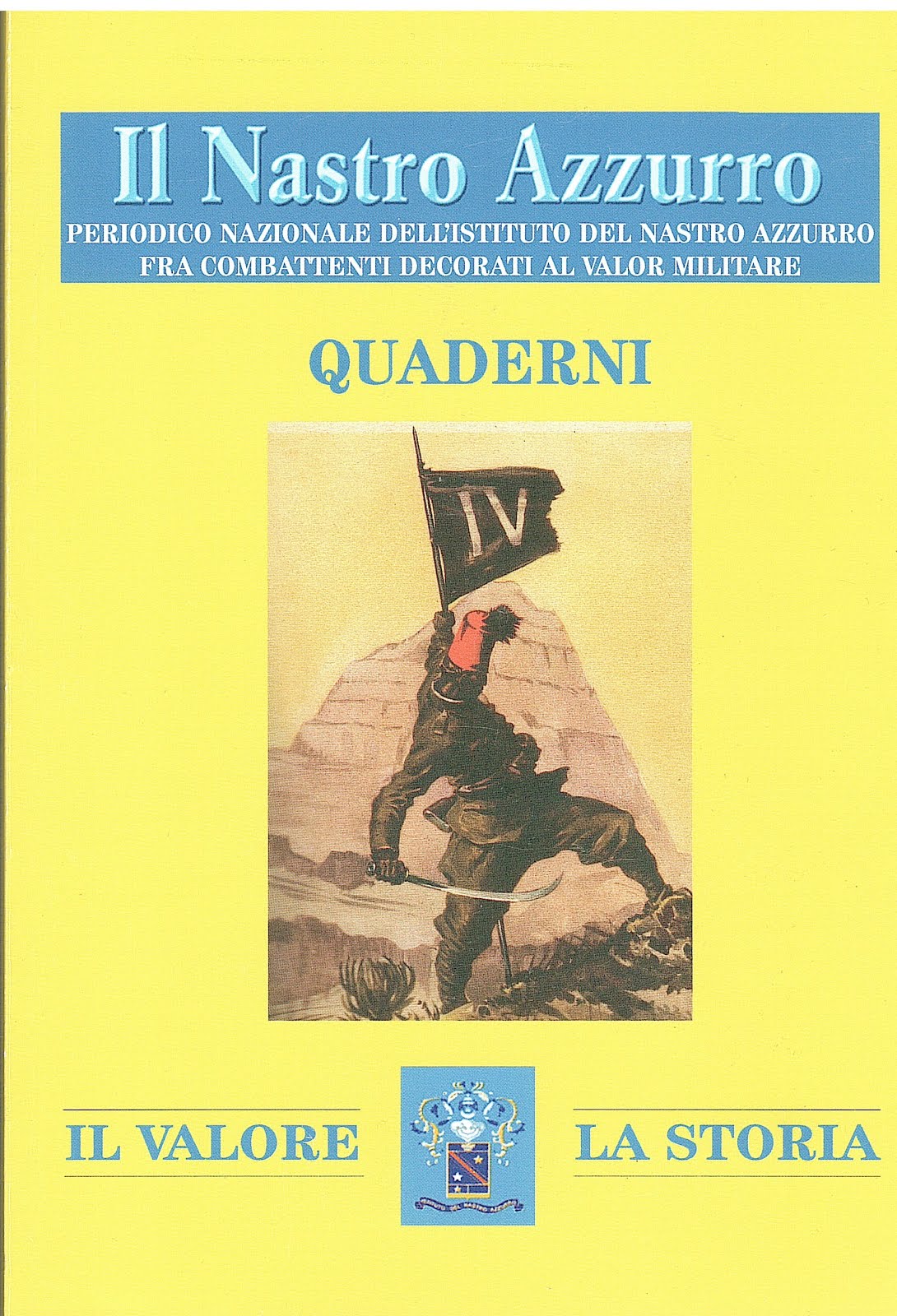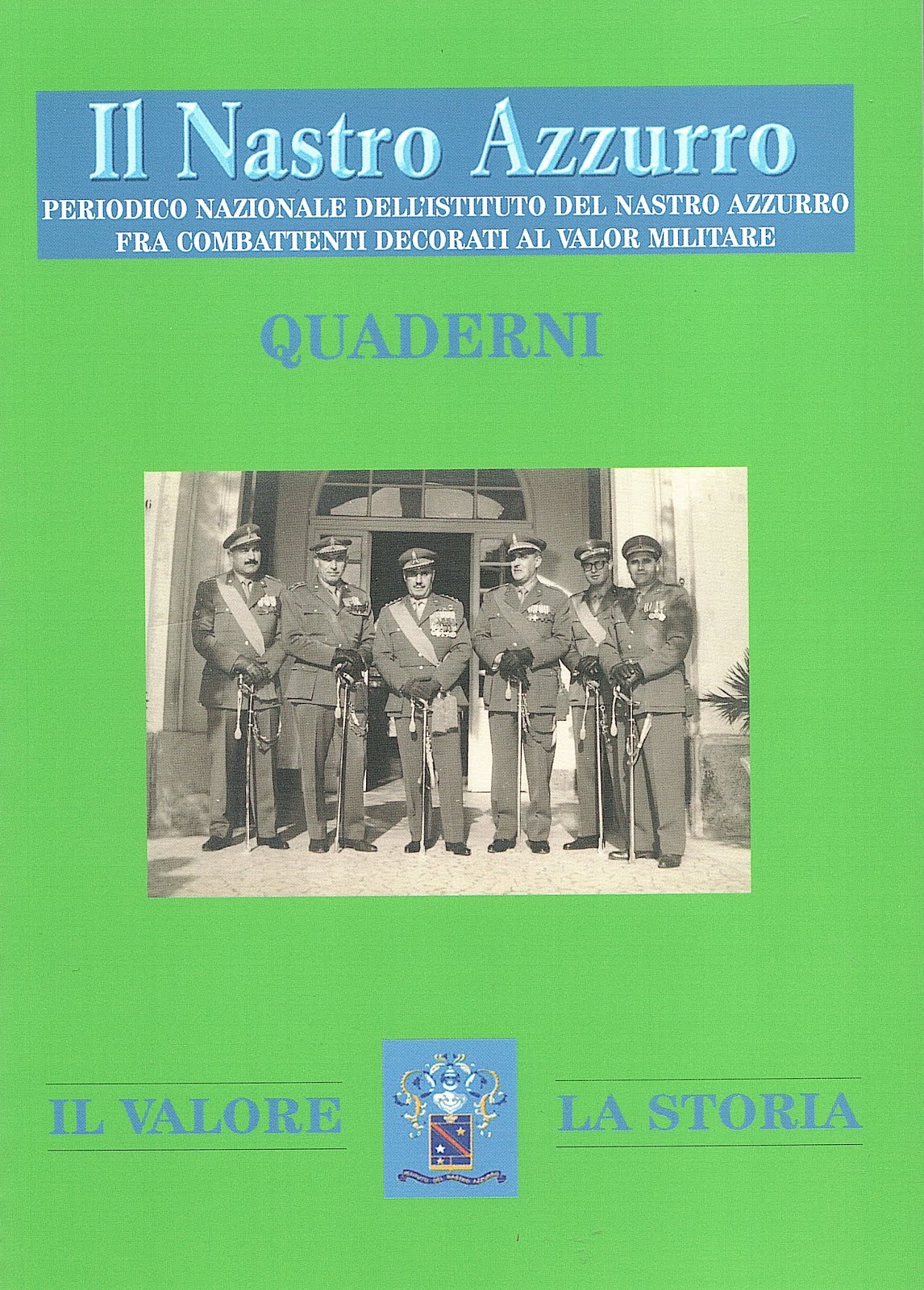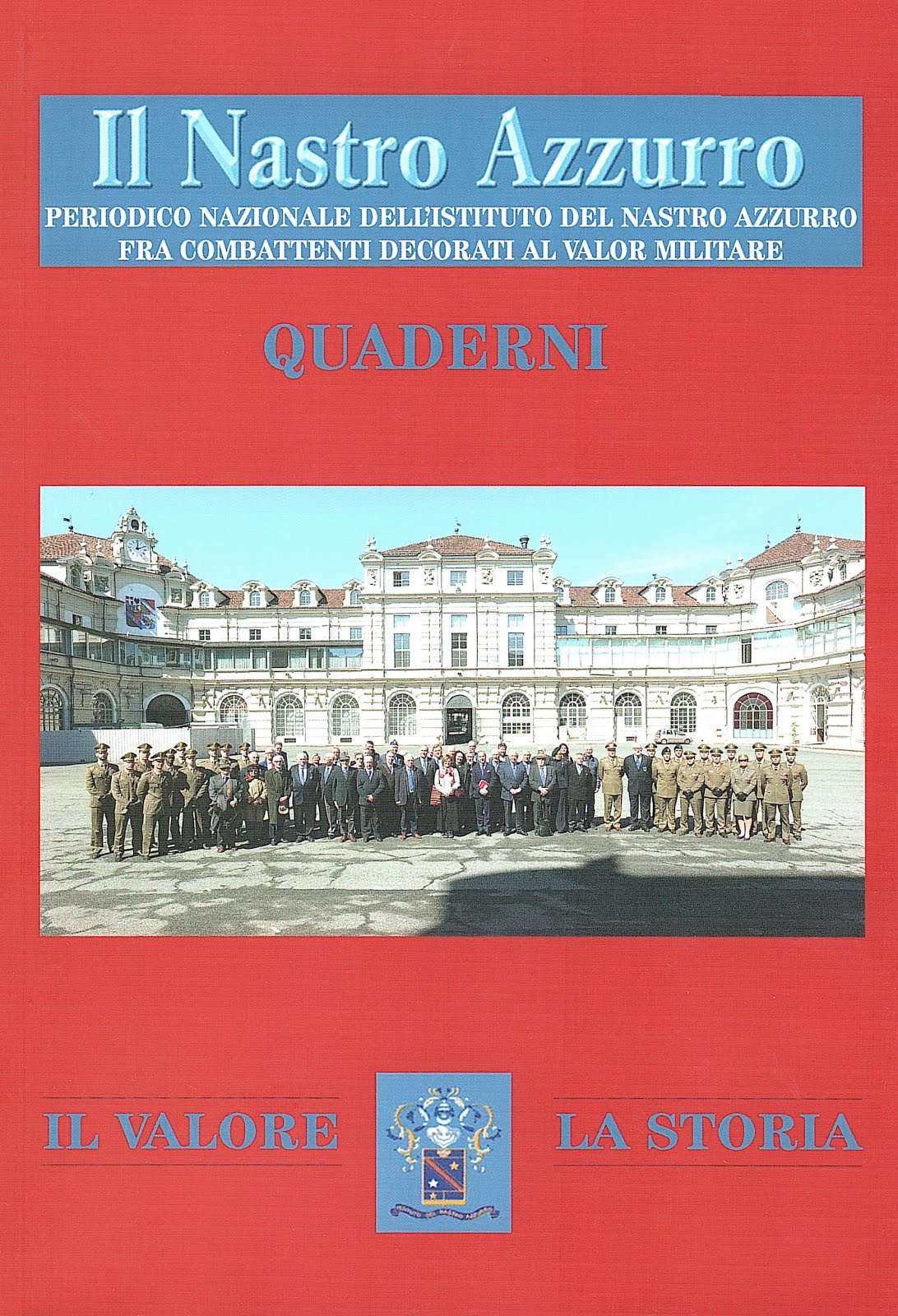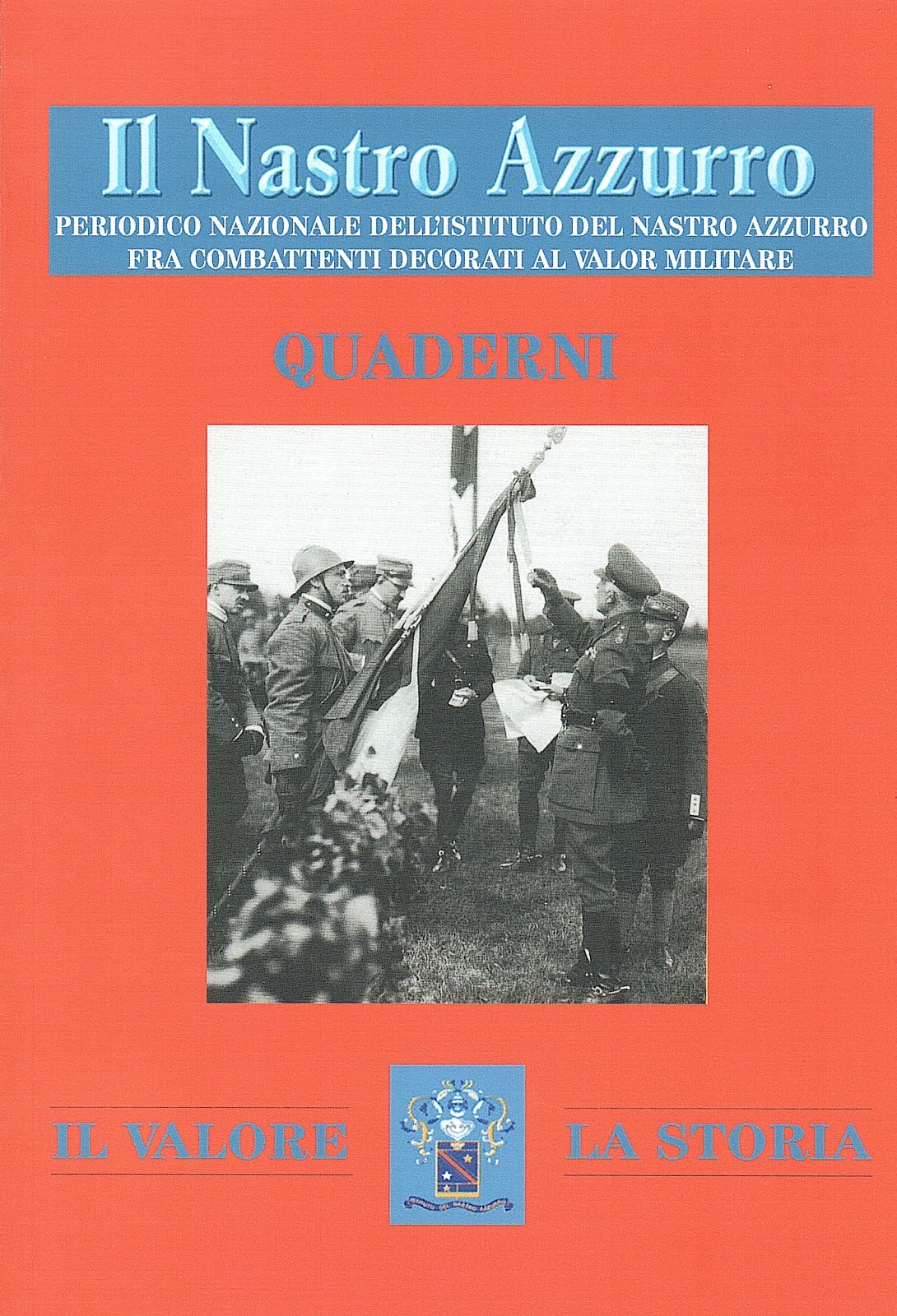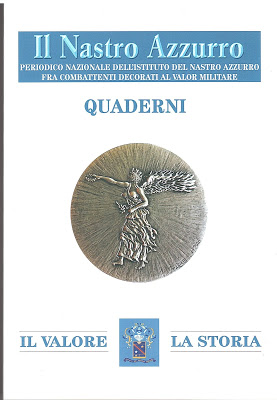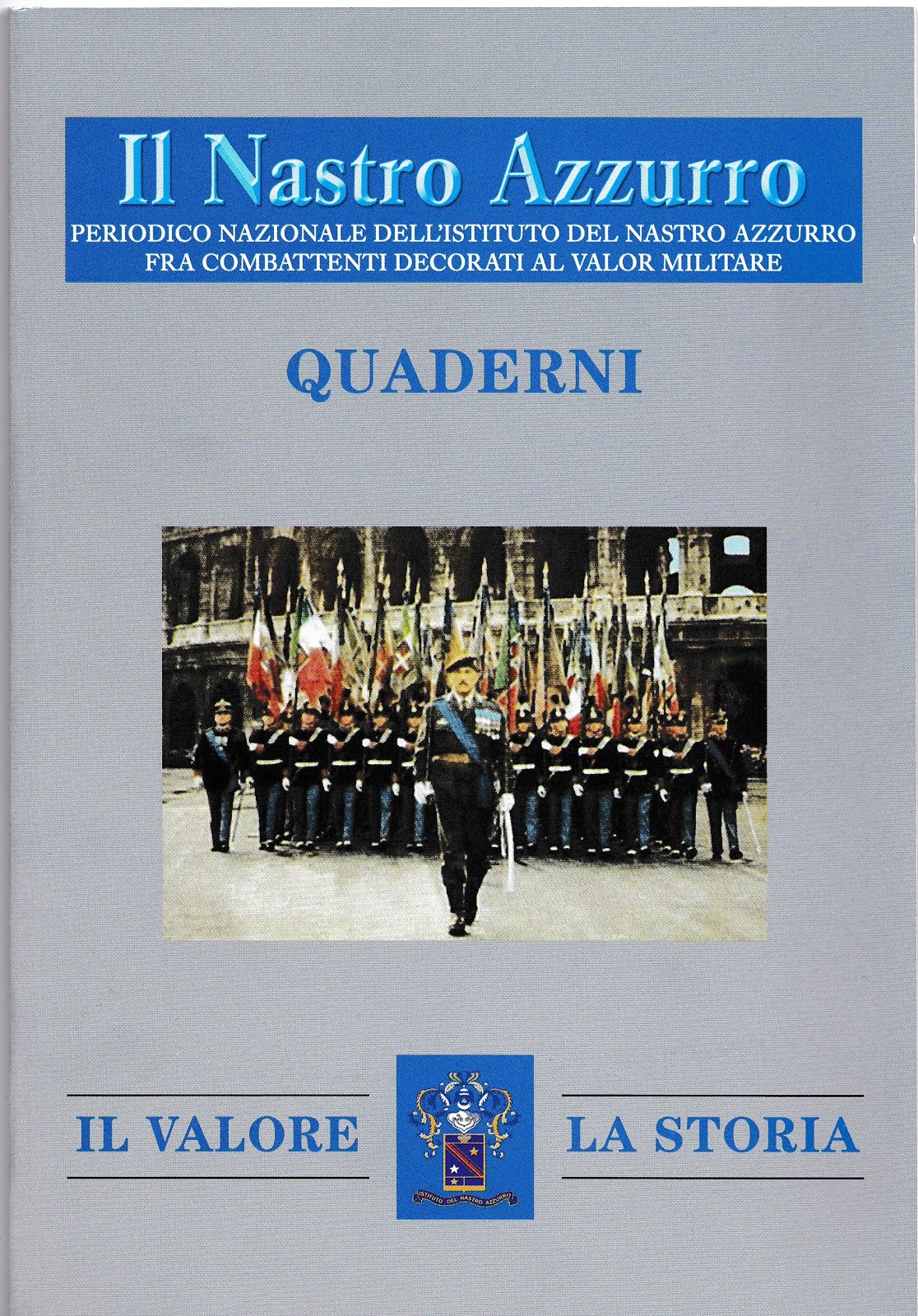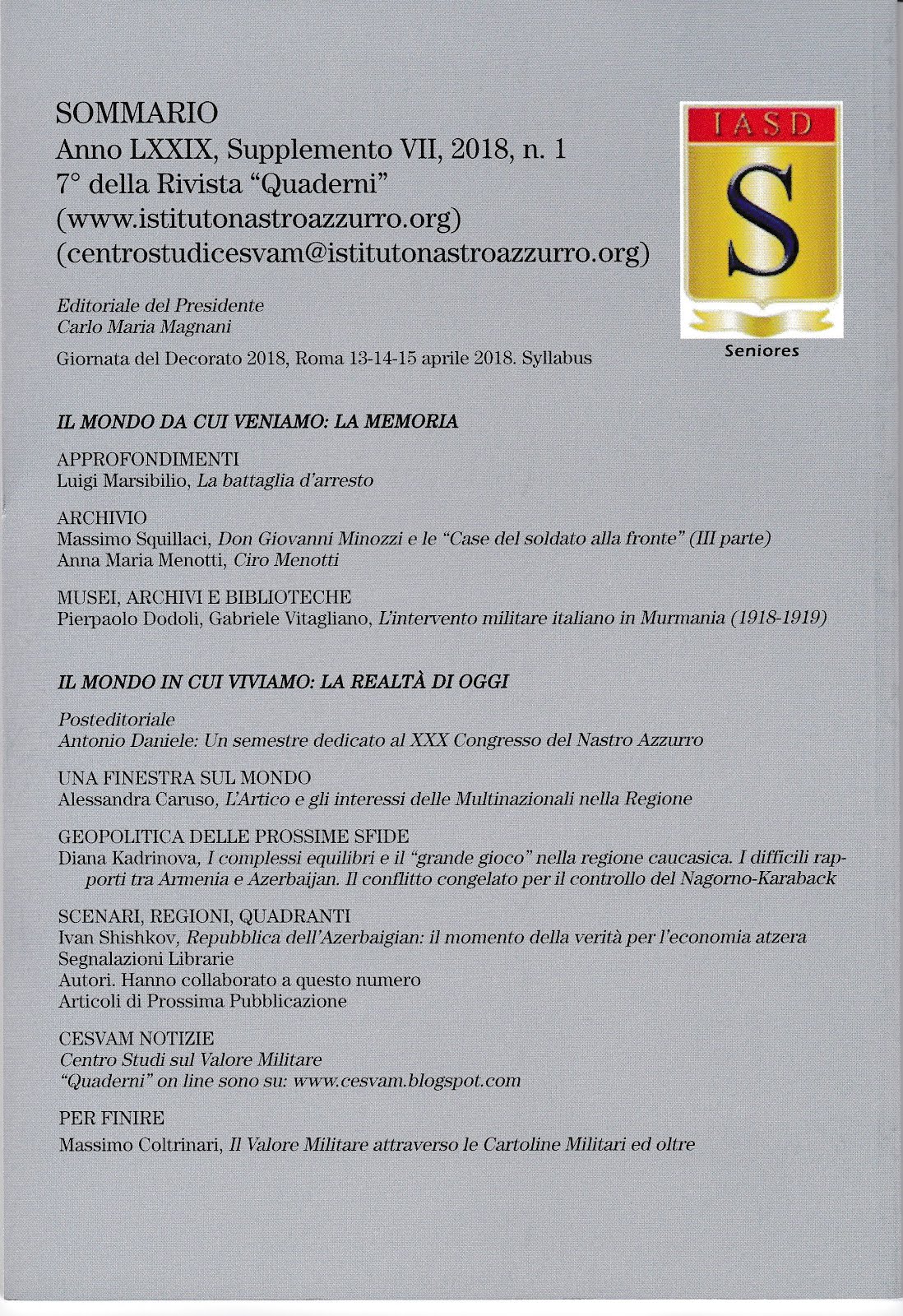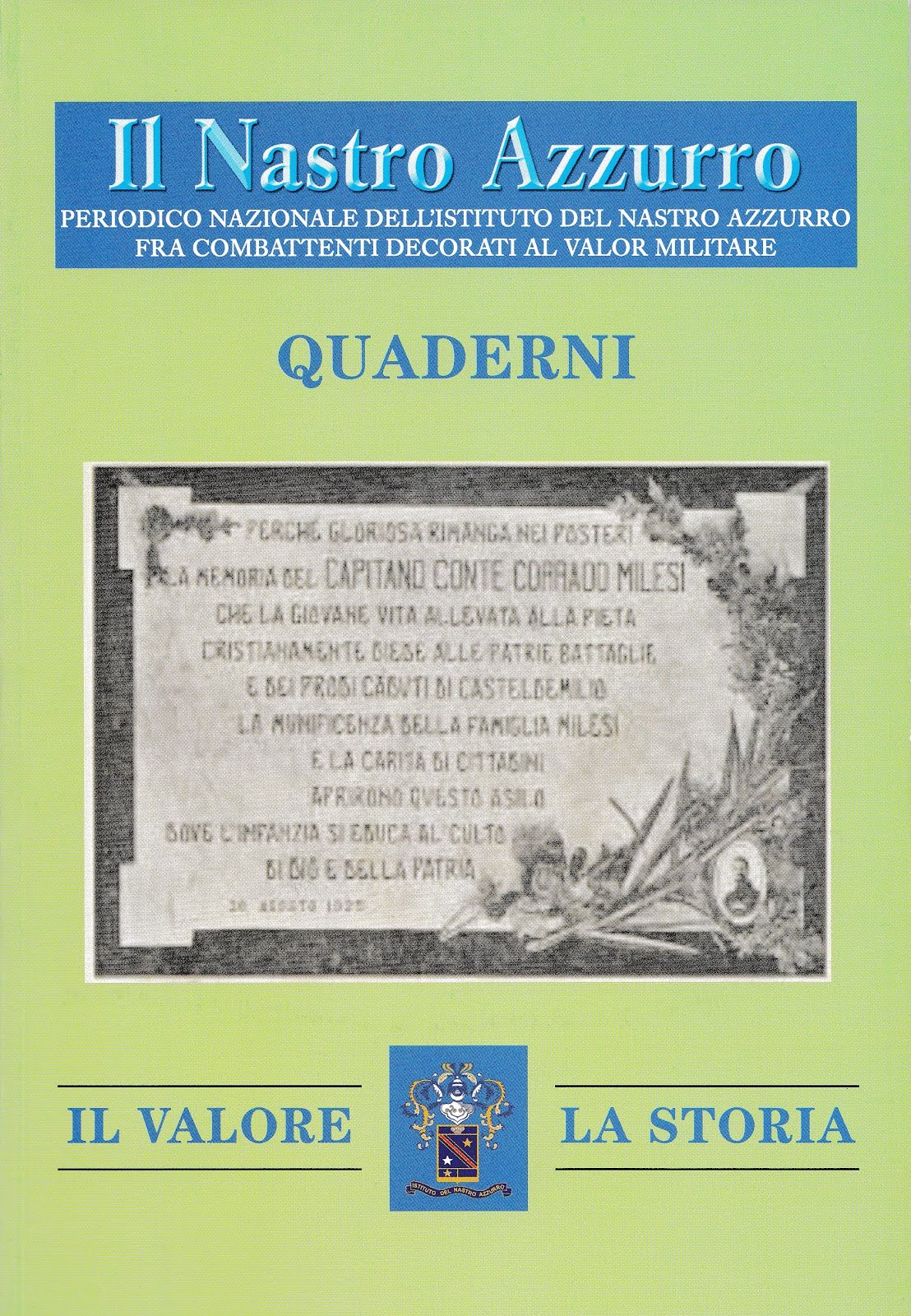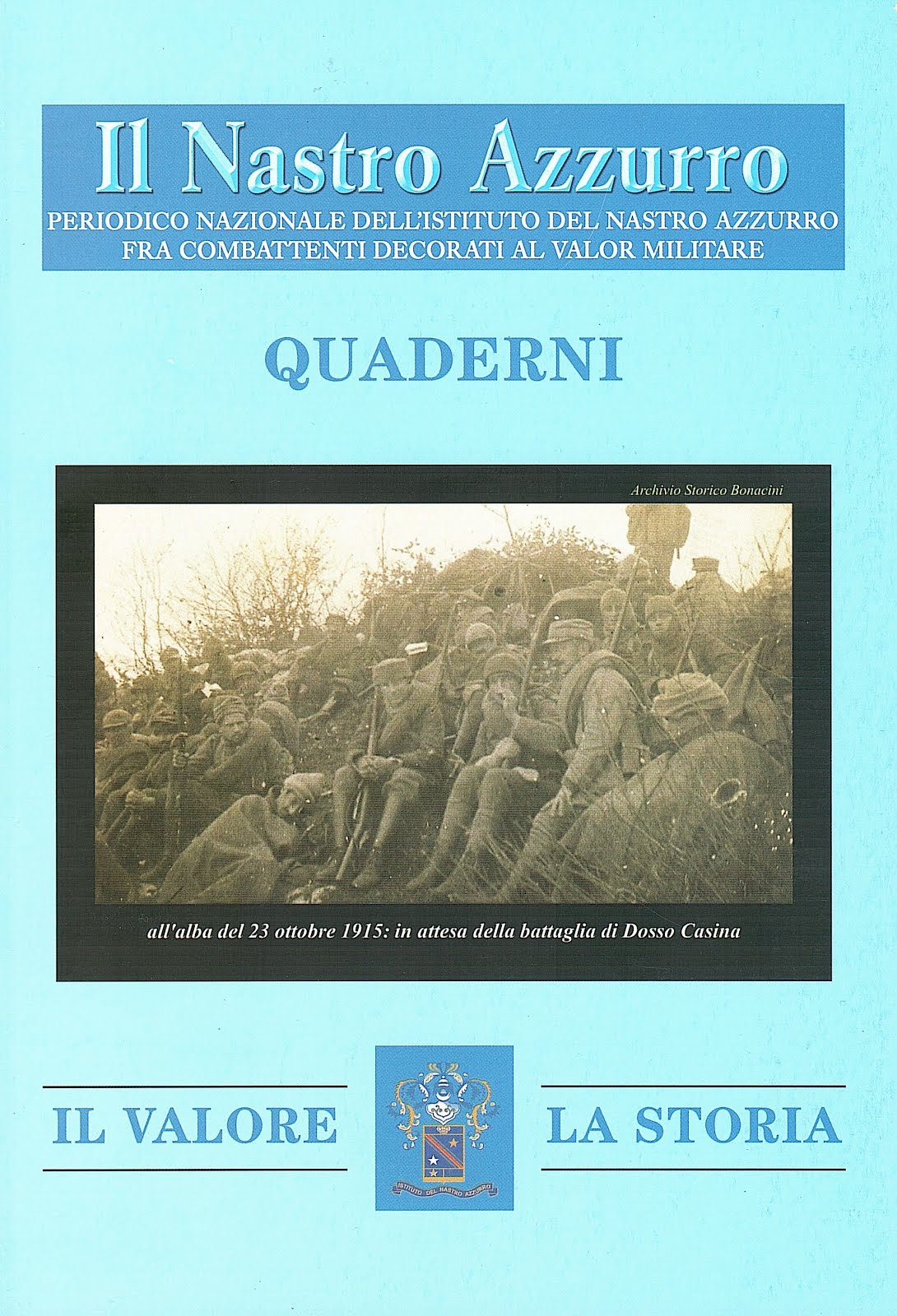Immigrazione
Onda libica sui flussi migratori
Fedora Gasparetti
27/02/2015
|
|
 Lo sviluppo della crisi in Libia e il conseguente aumento dei flussi migratori dal paese sta determinando una vera e propria emergenza umanitaria in Europa e soprattutto in Italia.
Lo sviluppo della crisi in Libia e il conseguente aumento dei flussi migratori dal paese sta determinando una vera e propria emergenza umanitaria in Europa e soprattutto in Italia.
Nonostante l’inverno, a gennaio 2015 3.528 migranti hanno attraversato il Mediterraneo (a differenza dei 2.171 registrati lo stesso mese nel 2014), mentre secondo i dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) a febbraio gli arrivi sono stati circa 4.300, 3.800 dei quali soltanto nel periodo compreso tra venerdì 13 e martedì 17.
“L’Europa deve essere pronta ad assistere in modo adeguato coloro che rischiano la propria vita in mare, ampliando i limiti geografici di intervento dell’operazione Triton e fornendo delle possibili alternative alla traversata via mare” afferma Federico Soda, Capo Missione dell’Oim in Italia.
Parole confermate dall’ennesima tragedia verificatasi nel Mediterraneo lo scorso 10 febbraio, evento che ha riacceso il dibattito sulle modalità di intervento dell’Europa evidenziando i limiti di Triton, la missione avviata dopo la chiusura dell’operazione Mare Nostrum coordinata dall’Italia.
Il tema è stato anche al centro del seminario L'immigrazione che verrà organizzato da “Area”, Magistratura democratica e Movimento per la Giustizia-Articolo 3, le cui conclusioni hanno sottolineato la necessità di un orientamento delle politiche europee e italiane volte ad assicurare condizioni di viaggio e di accoglienza dignitose e sicure.
L’attenzione i è concentrata anche sul rafforzamento delle risorse delle nuove iniziative europee (a partire proprio da Triton), portando l’esperienza di Mare Nostrum e allargandone il raggio d’azione e riconoscendo esplicitamente anche la finalità di soccorso dei migranti.
Rotta del Mediterraneo centrale
La traversata del mare in realtà costituisce solo la parte finale di un viaggio assai più complesso lungo la rotta del Mediterraneo centrale, una delle più sfruttate dai trafficanti da almeno una decina di anni e all’interno della quale la Libia rappresenta il nexus point dove confluiscono i migranti che sopravvivono al deserto e che provengono da differenti punti di partenza.
Fino al 2010, la relativamente prospera economia del paese offriva buone opportunità lavorative sia ai migranti subsahariani per i quali rappresentava la destinazione finale, sia per coloro che lo consideravano un paese di transito nel quale poter guadagnare il denaro sufficiente per pagare i trafficanti e continuare il viaggio alla volta dell’Europa.
In seguito alle Primavere arabe si è assistito ad un incremento sostanziale dei flussi in partenza dalle coste libiche per raggiungere principalmente l’Italia e Malta.
Nel 2014, 170.816 migranti sono approdati nel sud dell’Italia attraverso la rotta centro-mediterranea, rispetto ai 45.298 del 2013.
L’inasprimento recente dei conflitti ha conseguentemente favorito il business dei trafficanti, all’interno del quale si è inserito anche l’autoproclamatosi Stato islamico che si è conquistato la propria fetta di un mercato esistente ormai da lungo tempo.
In Libia confluiscono migranti provenienti da varie rotte interne gestite dai trafficanti, le cui principali includono l’attraversamento del Sahara a partire dal Sudan (intrapresa soprattutto da cittadini sudanesi e provenienti dal Corno d’Africa), dal Niger (percorsa in particolare da migranti subsahariani) e dal Chad (anche se di minore consistenza, questa via rappresenta un importante punto di passaggio per chadiani, sudanesi e camerunesi).
Anche siriani e palestinesi raggiungono la Libia dal Sudan dopo essere partiti in volo da Amman, Beirut o Istanbul alla volta di Khartoum e quindi attraversando il deserto libico. Tale opzione è una delle poche rimaste a queste due nazionalità dopo che il governo algerino ha reso loro estremamente difficile l’ottenimento del visto. Di conseguenza, la rotta attraverso l’Algeria è stata sostituita da quella alternativa via Sudan.
Flussi migratori multiforme
L’aggravarsi delle condizioni in Libia, la pericolosità del paese e le continue violenze ed estorsioni subite dai migranti (soprattutto di origine subsahariana) hanno costituito senza dubbio dei fattori decisivi nella scelta di imbarcarsi verso l’Italia, come riportano le testimonianze dei migranti arrivati in queste settimane.
Racconti che restituiscono la dimensione multiforme dei flussi migratori diretti verso l’Italia e che vede protagonisti sia migranti forzati, rifugiati e richiedenti asilo in fuga da conflitti che migranti economici e vittime di tratta.
Condizioni, queste, che influenzano notevolmente sia la durata e le condizioni della permanenza in Libia che il compenso corrisposto ai trafficanti (dai 400 ai 1500 dollari secondo i racconti degli intervistati).
L’attesa prima di partire può essere di cinque giorni come di due anni. Alcuni hanno riferito di aver passato dei mesi nelle cosiddette “case di collegamento”, dove sono stati vittime di sorprusi e violenze.
Un altro dato che emerge è quello relativo alle aspirazioni rispetto al paese ultimo di destinazione: dalla Germania al Nord Europa, mete il cui raggiungimento è facilitato dalle reti di trafficanti che si sono create anche all’interno dell’iperprotetto spazio Schengen.
Fedora Gasparetti è esperta di politiche migratorie e di asilo. Dottore di ricerca in Antropologia Sociale è stata consulente per diverse organizzazioni internazionali e nazionali. Per l’OIM ha lavorato in Tunisia, nel campo di rifugiati di Choucha al confine libico. Lavora attualmente per l’agenzia della Commissione Europea Eacea.
- See more at: http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2976#sthash.ZTnOr5Rp.dpuf