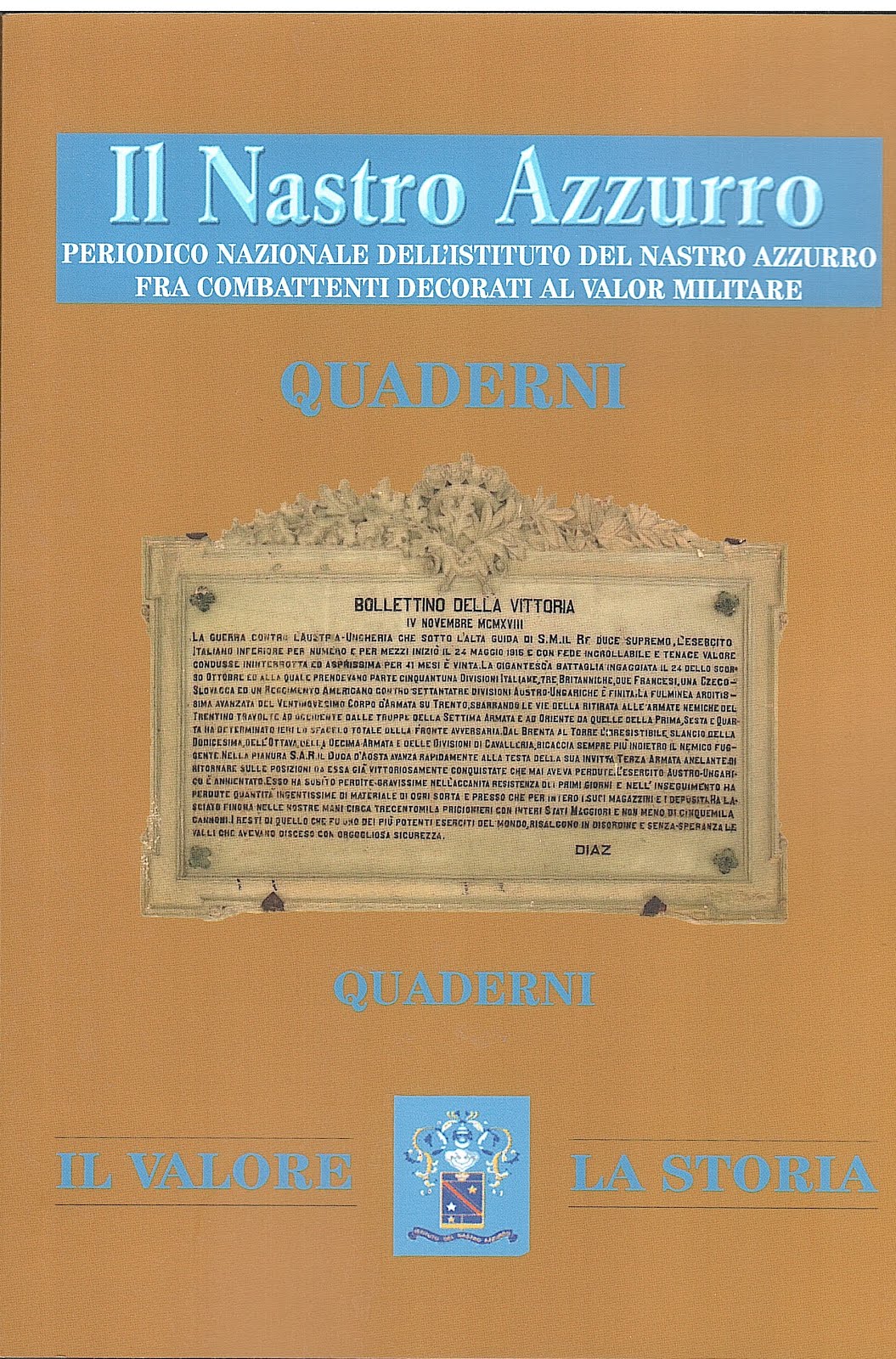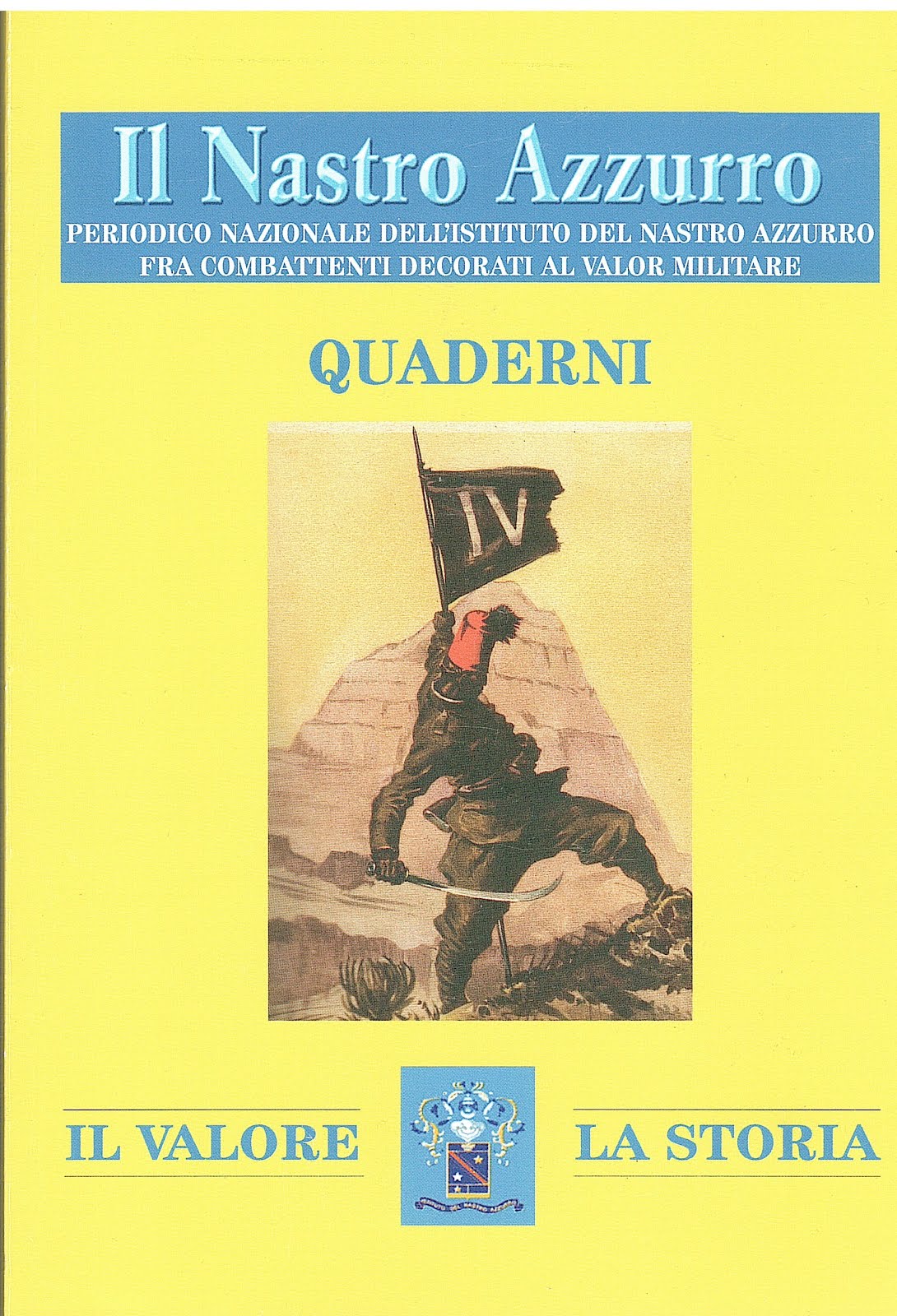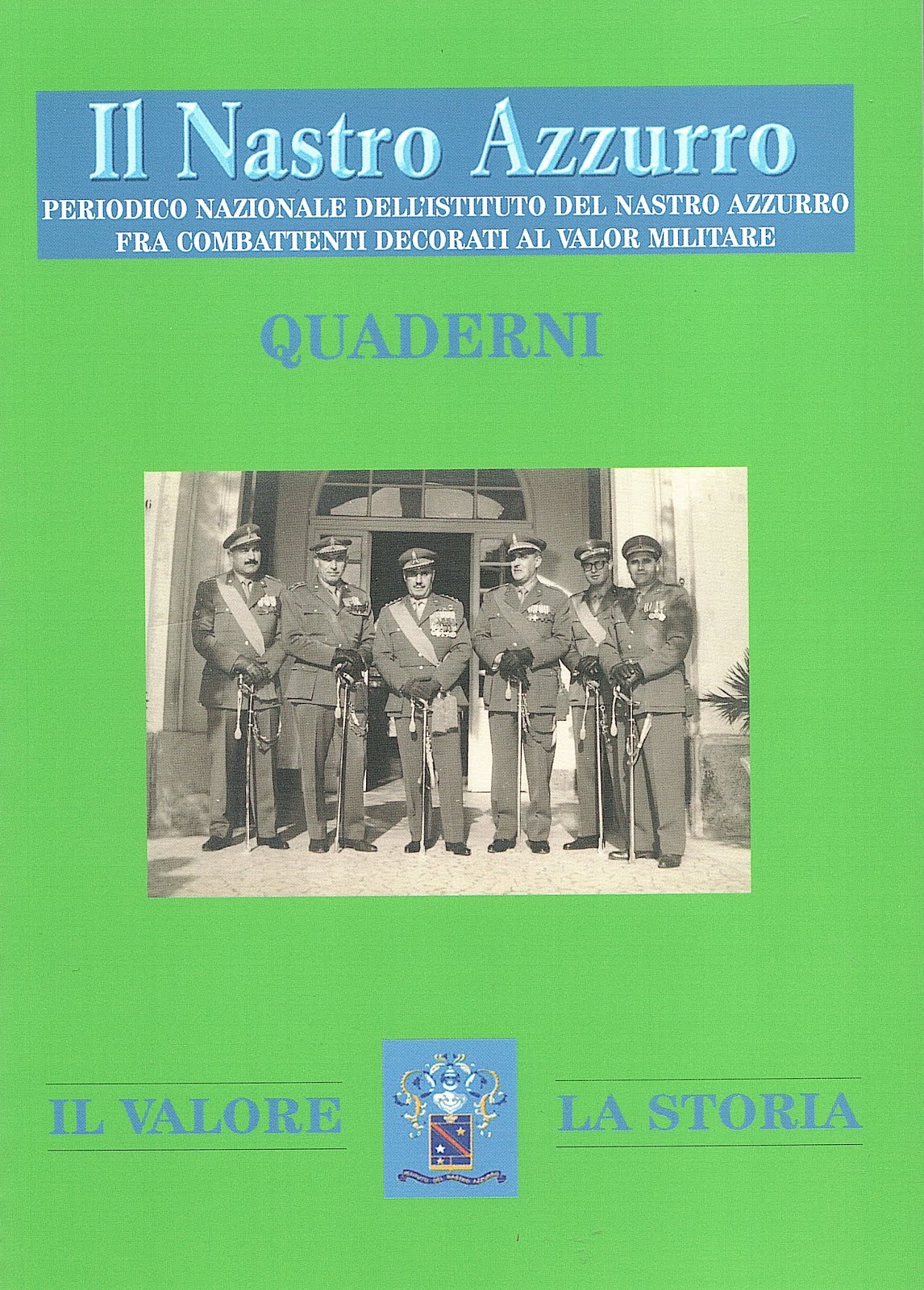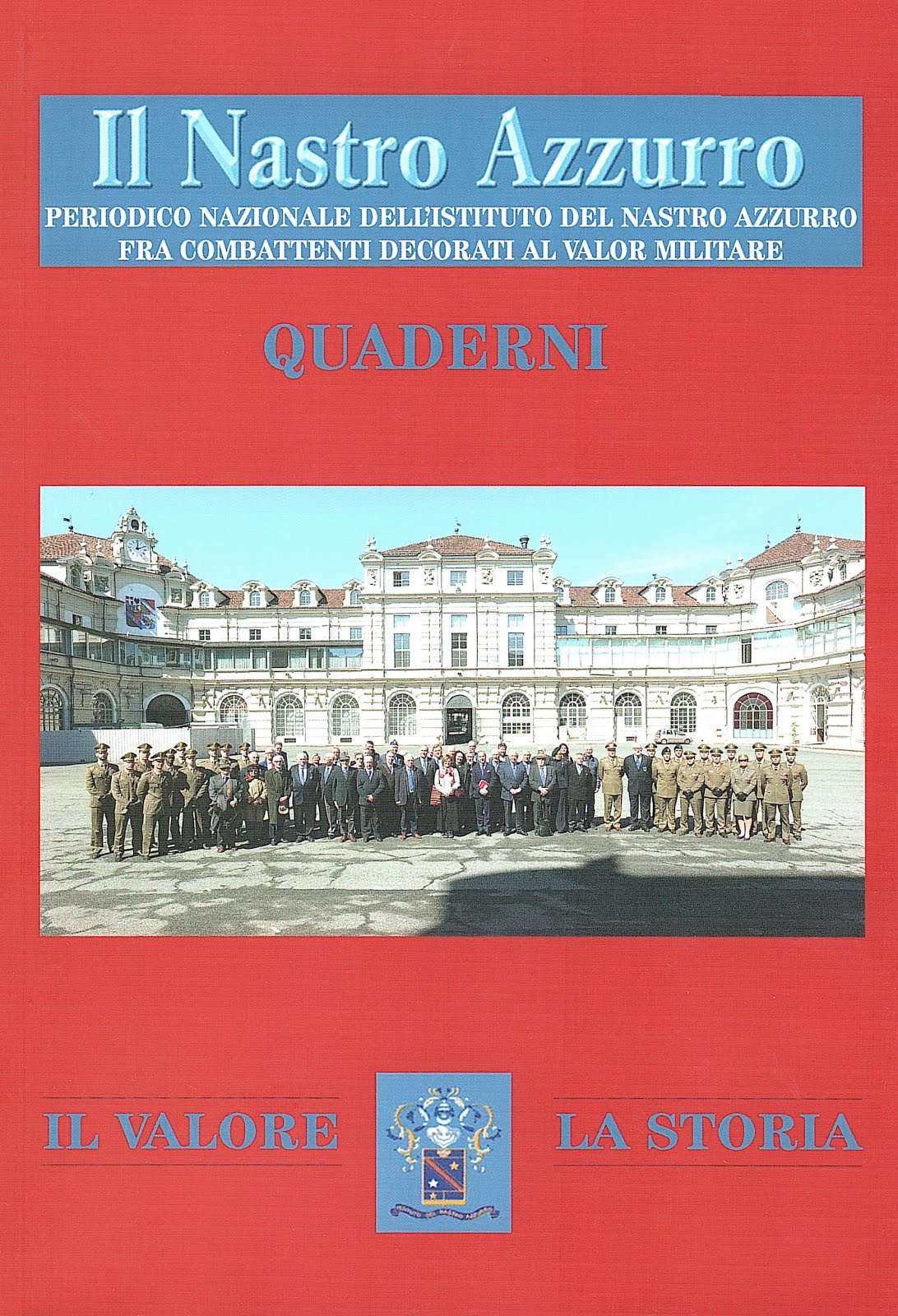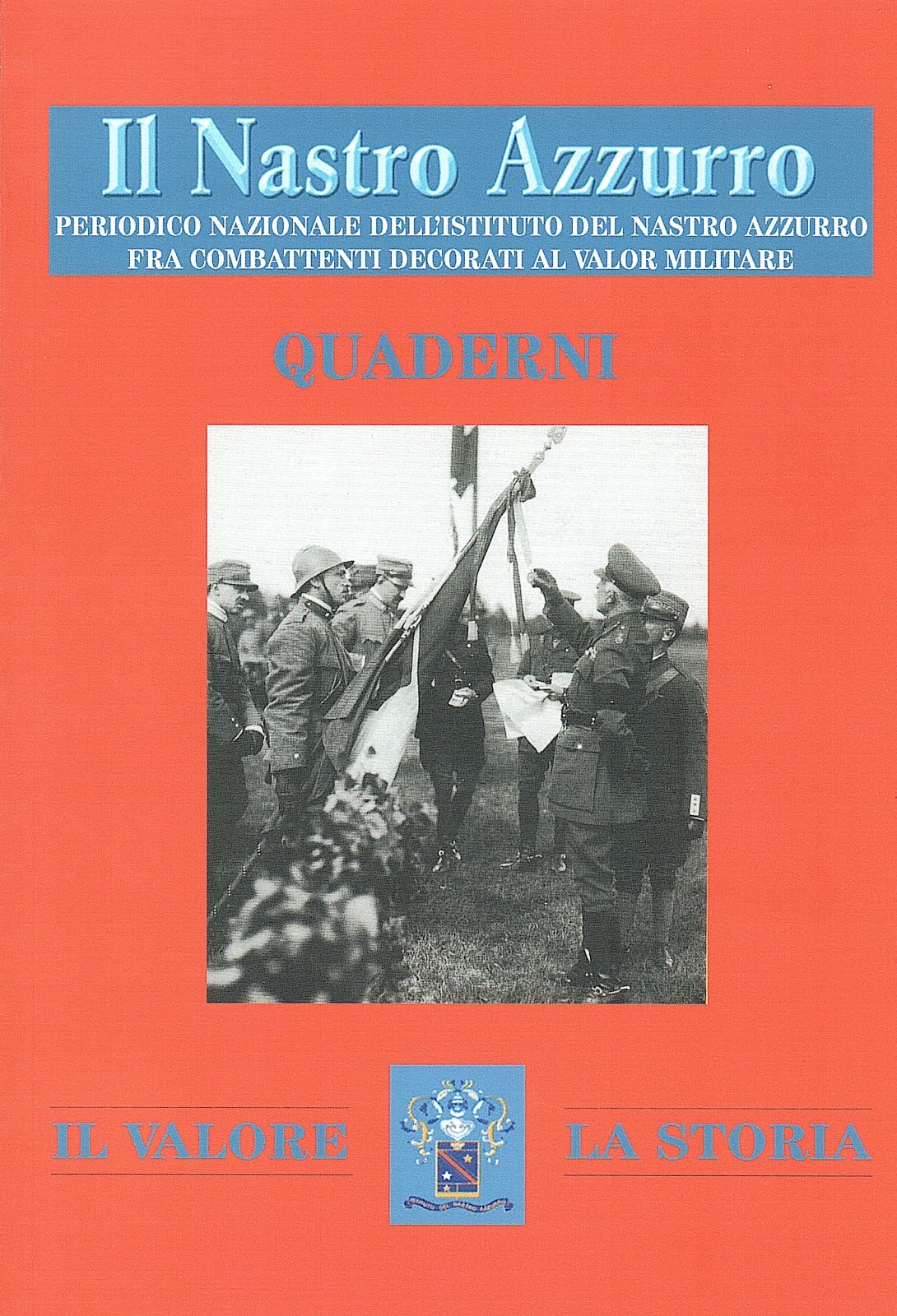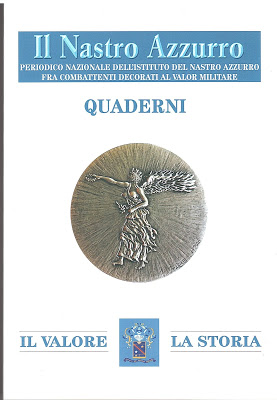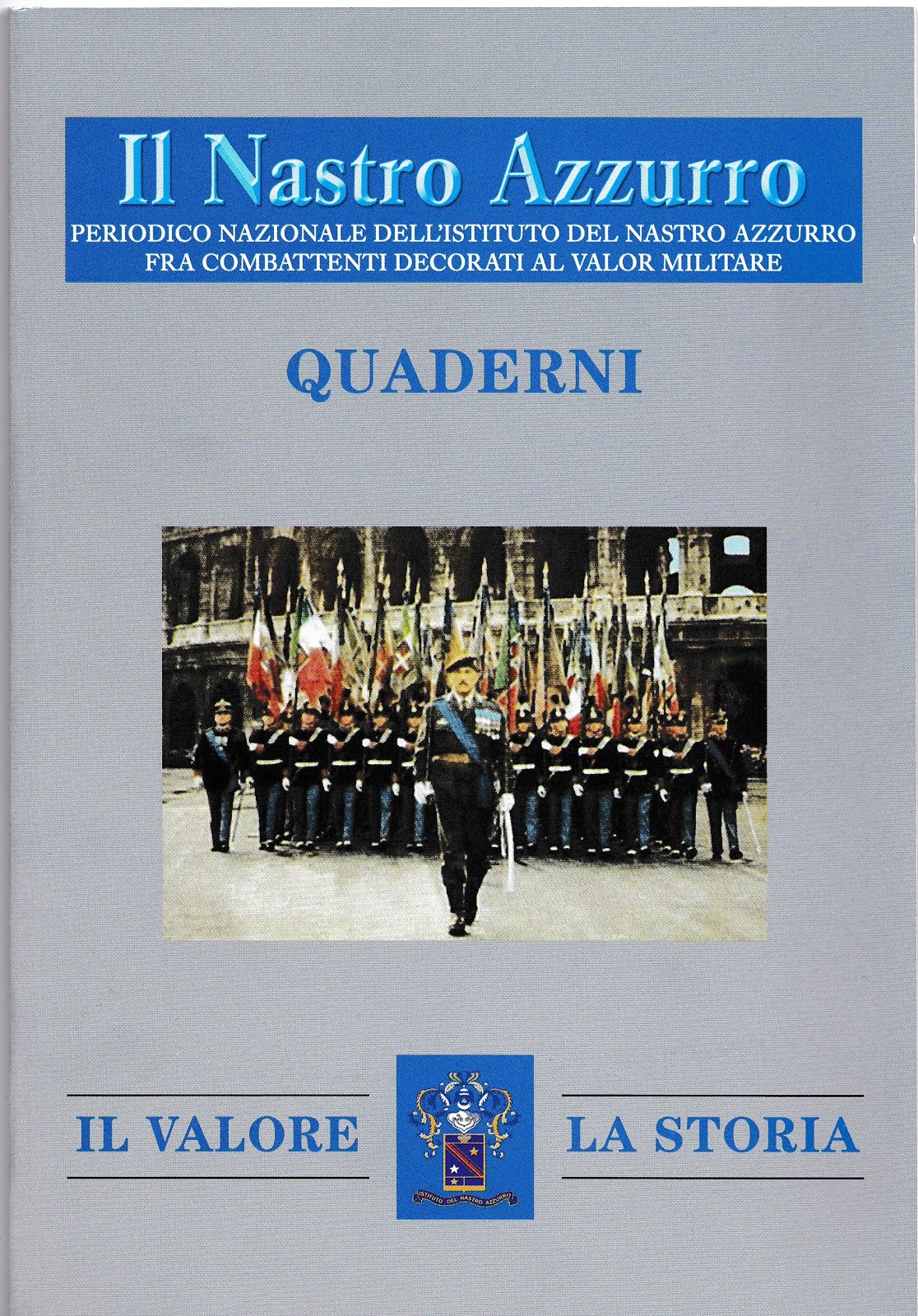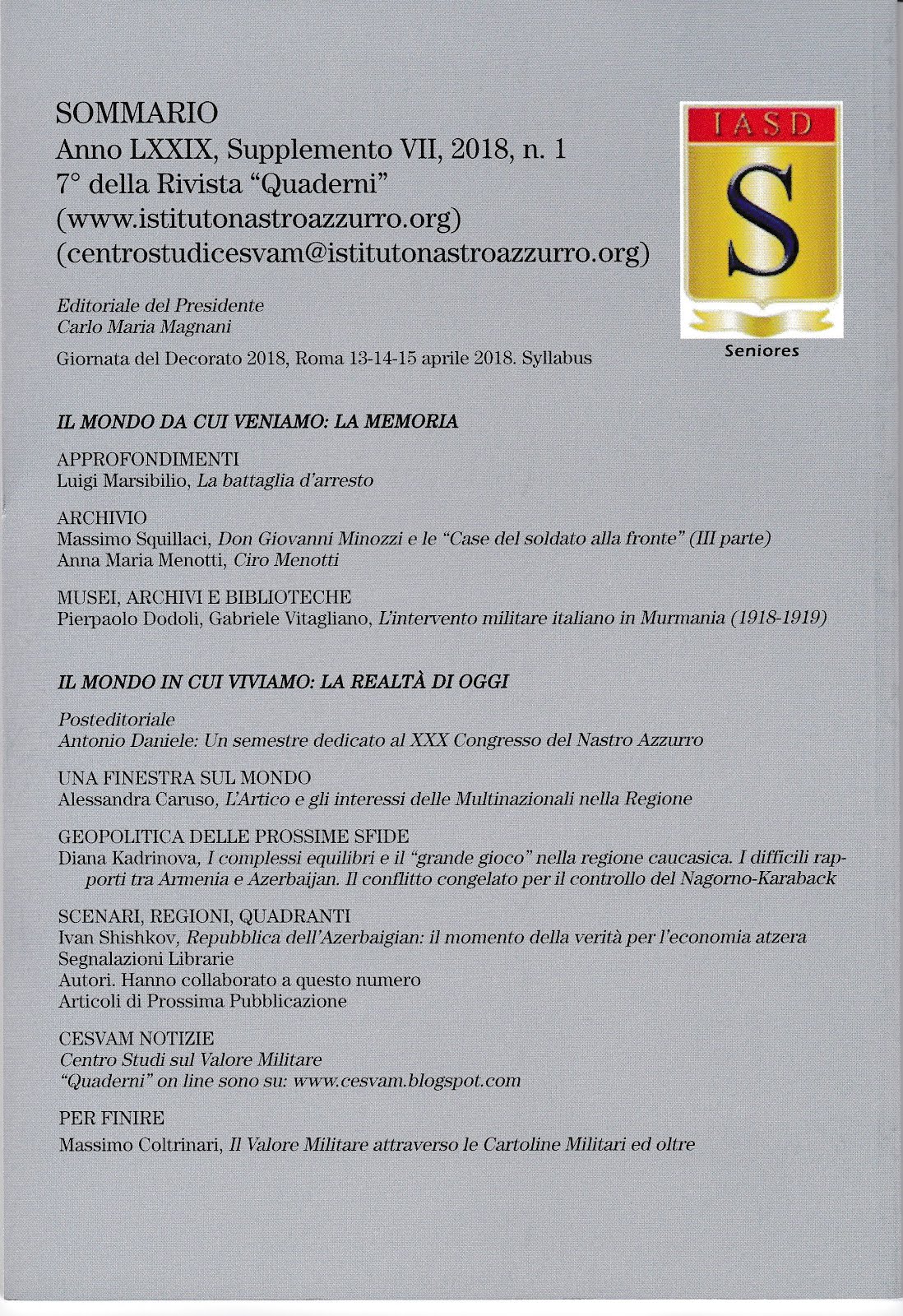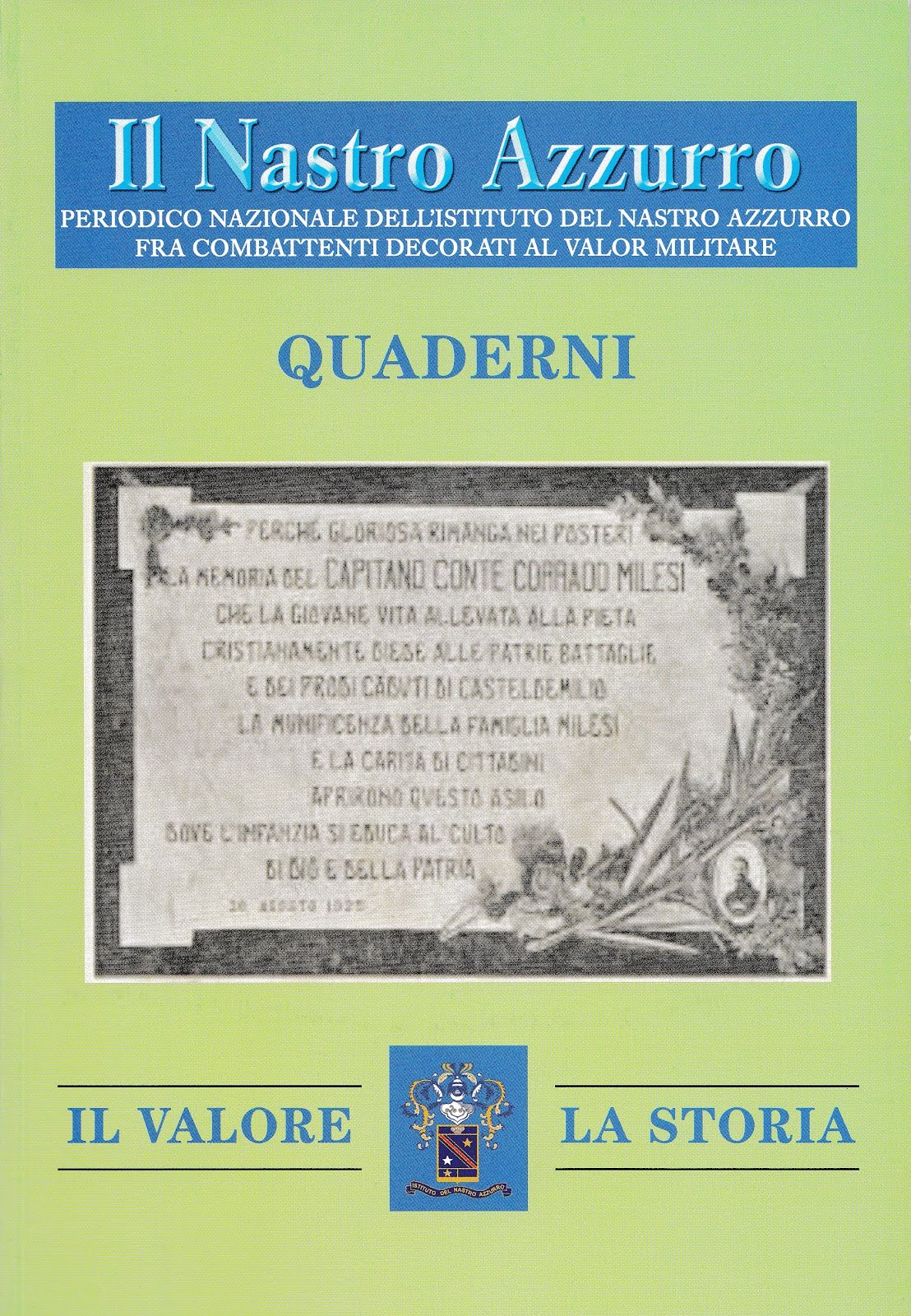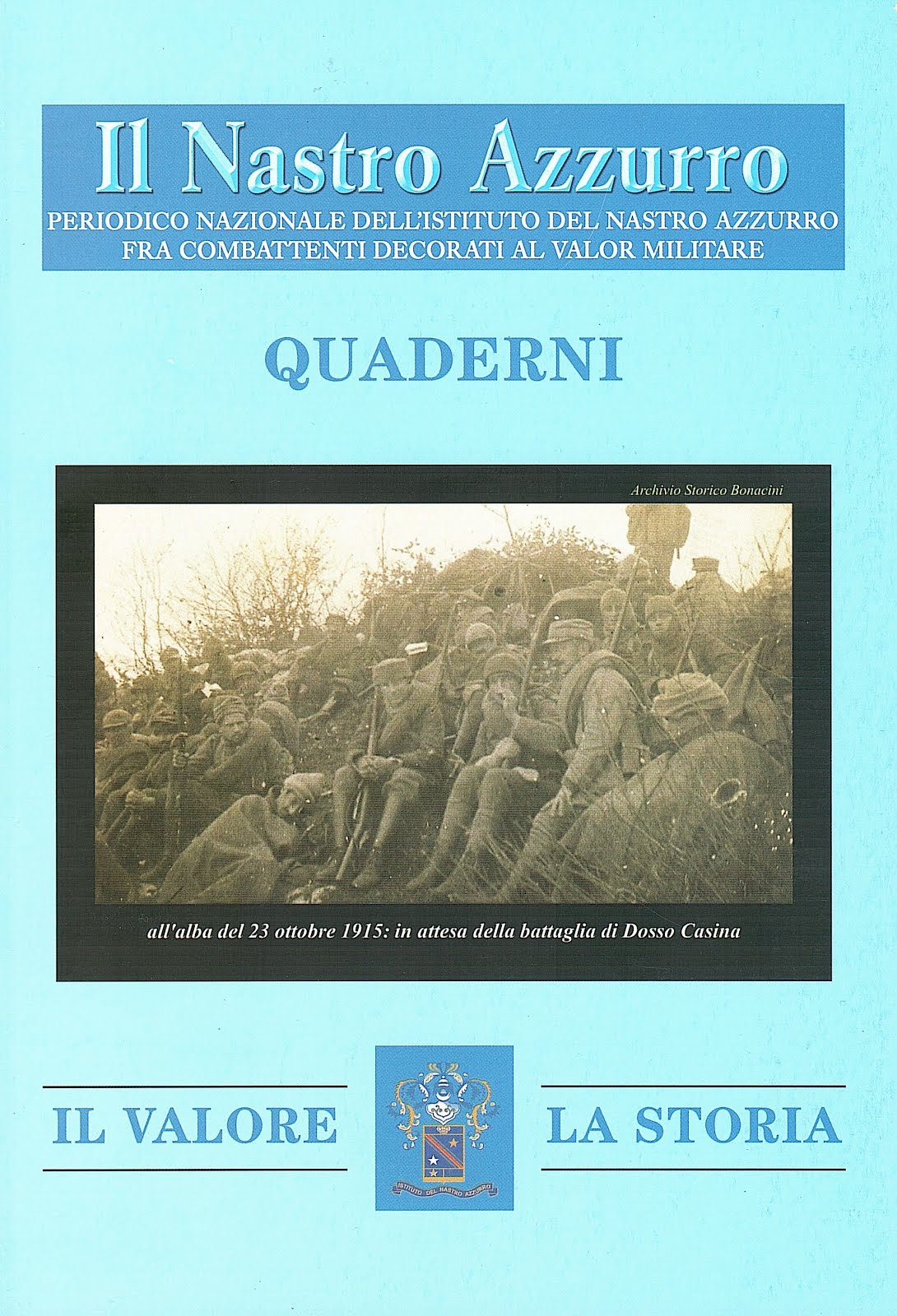Il Quantitative easing della Fed, l’invecchiamento demografico del Giappone, la Primavera araba e la minaccia di cambiamenti climatici sono eventi in apparenza distinti e distanti. Lo stesso vale per la politica monetaria di Mario Draghi, le elezioni presidenziali americane, il rallentamento dell’economia cinese, il rischio Brexit, il prezzo del petrolio, l’accordo sul nucleare con l’Iran. Il Quantitative easing della Fed, l’invecchiamento demografico del Giappone, la Primavera araba e la minaccia di cambiamenti climatici sono eventi in apparenza distinti e distanti. Lo stesso vale per la politica monetaria di Mario Draghi, le elezioni presidenziali americane, il rallentamento dell’economia cinese, il rischio Brexit, il prezzo del petrolio, l’accordo sul nucleare con l’Iran.
In realtà sono fenomeni molto più intrecciati di quanto non sembri. I collegamenti tra politica monetaria, crescita economica e affari internazionali ci sono sempre stati ma oggi sono tali da aumentare esponenzialmente la difficoltà di comprendere i rapporti causa-effetto e di gestire efficacemente le crisi. Lo studio delle interdipendenze nel mondo attuale è quindi fondamentale per i policy-maker.
Il mondo semplice dei blocchi contrapposti
Complessità e interdipendenze sono aumentate rapidamente. Solo qualche decennio fa il mondo era più “semplice”. In politica estera, la netta contrapposizione tra i due blocchi della “guerra fredda” garantiva il mantenimento di un certo equilibrio. Le crisi erano in gran parte gestite con accordi, espliciti o di fatto, tra Washington e Mosca. In caso di conflitto, nemici e alleati erano facilmente identificabili.
In campo economico, la ripartizione era tra paesi industrializzati e in via di sviluppo. Gli Stati Uniti erano l’unica vera locomotiva che trainava l’economia mondiale attraverso importazioni di merci ed energia e gran parte del mondo finanziava i due grandi deficit americani.
I fattori di crescita erano chiari. Le decisioni della Fed le uniche veramente rilevanti, alle quali le altre Banche centrali si adeguavano. L’utilizzo delle leve tradizionali di politica monetaria a Washington determinava conseguenze in larga misura prevedibili sull’economia statunitense e mondiale. Anche in campo economico le crisi erano gestibili in gruppi ristretti come il G7.
Gli schieramenti erano definiti anche in campo energetico: da una parte i paesi produttori di petrolio e dall’altra quelli industrializzati importatori di energia. Molti dei primi erano organizzati nel cartello dell’Opec. I secondi, con grandi fabbisogni e poche fonti alternative, particolarmente vulnerabili ad aumenti del prezzo del greggio. Anche in questo caso, la realpolitik facilitava accordi e compromessi nelle situazioni di crisi che potevano incidere su prezzo e forniture di petrolio.
Bipolarismo, teoria dei giochi e comportamenti razionali
Nel mondo “semplice” dei blocchi gli attori erano pochi e si conoscevano bene. Politica estera e politica economica erano una sorta di partita a scacchi tra giocatori razionali. La fiducia reciproca era poca ma, prendendo a prestito la terminologia della teoria dei giochi, la “ripetizione del gioco” garantiva comportamenti razionali da parte dei giocatori.
La teoria dei giochi dimostra che un atteggiamento di cooperazione produce maggiori vantaggi rispetto a uno egoistico. A patto che ci sia fiducia reciproca tra gli attori, oppure che si abbia un approccio di lungo periodo (cioè che il gioco sia ripetuto più volte) che induca a comportamenti razionali.
Il dilemma del prigioniero - una delle versioni più semplici di game theory, applicato a economia, politica internazionale, strategia militare, ecologia - mostra come un comportamento egoista da parte dei giocatori arrechi un danno generale mentre, al contrario, un atteggiamento di cooperazione razionale sia la soluzione migliore per tutti.
Il presupposto è che tutti i “giocatori”, non solo uno, si comportino in modo cooperativo. Ciò è più facile che avvenga se i giocatori sono pochi, si conoscono reciprocamente e tendono a rimanere gli stessi nel tempo.
Dall’unica superpotenza al mondo multipolare
Con la fine della guerra fredda e un prolungato periodo di diffusa crescita economica cambiano gli equilibri politico-economici mondiali. Nell’arco di tempo tra le due date simboliche del 9 novembre 1989 (caduta del muro di Berlino) e dell’11 settembre 2001 (attacco terroristico al World Trade Center di New York), gli Stati Uniti sono l’unica superpotenza politica, militare ed economica a livello globale.
In questa veste, Washington riesce quindi a imporre al mondo un atteggiamento “cooperativo”. Ciò facilita la gestione delle crisi e il raggiungimento di equilibri internazionali. È l’applicazione sul piano internazionale di quanto intuito dal filosofo inglese Hobbes quattro secoli prima, con riferimento agli stati nazionali. Per Hobbes la soluzione alle naturali tensioni tra gli uomini è la “costrizione”: in questo contesto, l’introduzione dello Stato, con le sue leggi, garantisce la collaborazione tra i cittadini.
Gli Stati Uniti, grazie alla forza economica, a quella politico-militare e alla Fed, hanno esercitato questo ruolo con buoni risultati per l’equilibrio mondiale. Oggi, pur rimanendo Washington la principale superpotenza, è emerso un nuovo scenario multipolare caratterizzato da un elevato numero di attori e dalla loro crescente interdipendenza. I rapporti causa-effetto, in tutti i settori, sono molto più complessi da decifrare, le crisi più impegnative da gestire e le decisioni di policy più difficili da prendere.
Il mondo complesso delle interdipendenze
In politica estera, il parziale disimpegno degli Stati Uniti da molti fronti e l’affermarsi di diverse potenze regionali hanno fatto saltare molti equilibri e aumentato il grado d’incertezza. Le vicende di Siria, Libia e Iraq ne sono un esempio.
In economia, i motori di crescita mondiale sono oggi almeno quattro: Stati Uniti, Europa, Cina ed economie emergenti. Da una parte, ciò allarga la base della crescita, dall’altra rende più difficile utilizzare efficacemente i tradizionali strumenti di politica fiscale e monetaria.
La politica monetaria espansiva della Fed volta a far uscire gli Stati Uniti dalla crisi spinge i capitali alla ricerca di rendimenti verso settori a rischio e paesi emergenti. E genera bolle speculative difficili da controllare e pericolose per tutti.
È accaduto a inizio anni ’90 con il Sudest asiatico, dopo il 2001 con il mattone e rischia di ripetersi in Brasile. D’altra parte la mera aspettativa di aumento dei tassi americani sta provocando nervosismo nei mercati finanziari, rientri di capitale negli Stati Uniti e rafforzamento del dollaro, con il rischio di mettere in ginocchio molte economie emergenti.
Anche i prezzi di petrolio e commodity sono importanti. Il picco del greggio di un paio d’anni fa, evento in passato indiscutibilmente negativo per Washington, ha incoraggiato gli investimenti nell’estrazione di shale gas avvicinando gli Stati Uniti all’indipendenza energetica.
D’altro canto, il recente crollo del petrolio, certamente favorevole per le economie industrializzate, produce effetti collaterali e rischi anche per Europa e Stati Uniti. Tra questi, la difficoltà dei paesi produttori di petrolio a finanziare la spesa pubblica, con conseguenti rischi d’instabilità sociale e politica. Si pensi a Russia, Arabia Saudita e Nigeria.
Lo stesso vale per i prezzi di altre materie prime, in particolare dei generi alimentari che nei paesi in via di sviluppo sono importanti per la stabilità interna. Si ricordi che la Primavera araba nel 2011 coincide con il picco dei prezzi delle materie prime.
Infine, nel mondo “complesso” anche i cambiamenti climatici sono sempre più un rischio per la crescita economica e la stabilità dei mercati finanziari. L’accordo COP21 a Parigi ha quindi una forte valenza internazionale anche da un punto di vista economico.
Equilibri instabili e “terzo paradigma” di Caillé
Nel mondo multipolare di oggi, ogni paese ha la tentazione di perseguire il proprio interesse. Ciò rende molto più complesso raggiungere equilibri e affrontare con efficacia le crisi. Nonostante anche nei “giochi complessi” la soluzione più razionale e più conveniente per i diversi attori sia la collaborazione reciproca, la tentazione di giocare “contro” gli altri è più forte.
In questo contesto la “costrizione” a cooperare à la Hobbes è ardua, forse impossibile. Non la possono e vogliono esercitare più gli Stati Uniti e non è in grado di realizzarla l’Onu. L’alternativa è la fiducia, al contempo fonte e risultato di forti relazioni tra le parti. Solo in presenza di fiducia reciproca, infatti, i governi, le economie e le istituzioni possono entrare in relazioni di cooperazione. L’introduzione di quello che il sociologo francese Alain Ciallé chiama il “terzo paradigma”, basato sulla relazione, può aiutare a superare le contrapposizioni e raggiungere equilibri tra gli attori.
Nel mondo complesso di oggi, fenomeni apparentemente distanti sono in realtà fortemente intrecciati. Ciò rende difficile raggiungere situazioni di equilibrio e gestire le crisi. In tutti i settori.
Le alternative sono due: il caos, che spesso porta a situazioni di conflitto, o l’aumento della cooperazione, per ottenere la quale è necessario migliorare la qualità delle relazioni tra paesi e istituzioni. Il punto di partenza è formare una classe dirigente che comprenda a fondo le interdipendenze tra i fenomeni di politica monetaria, crescita economica e affari internazionali.
Marco Magnani è Fellow allo IAI e Senior Research Fellow alla Harvard Kennedy School; ha pubblicato “Sette Anni di Vacche Sobrie” (Utet), Creating Economic Growth (PalgraveMamillan), Terra e Buoi dei Paesi Tuoi (Utet) e collabora con IlSole24Ore. Nell’autunno 2016 offrirà il corso Monetary Policy, Economic Growth and International Affairs a Scienze Politiche della Luiss. (Twitter @marcomagnan1) www.magnanimarco.com.
|