| ||||||||
Molta meno attenzione è stata dedicata invece al Corridoio Meridionale del Gas (Southern Gas Corridor), il progetto sponsorizzato dall’Unione europea, Ue, che punta alla diversificazione delle importazioni del gas. L’assenza di un dibattito critico, soprattutto negli ambienti istituzionali europei e nazionali, è sorprendente a fronte dei rischi e delle scelte che comporta il sostegno al Corridoio. Il Corridoio Meridionale del Gas Il progetto mira a ridurre la dipendenza europea dalle importazioni di gas russo. Esso prevede quattro fasi. La prima riguarda l’estrazione del gas e l’infrastrutturazione del giacimento di gas naturale Shah Deniz-2 nel mar Caspio, in territorio azero. La seconda comprende l’espansione della South Caucasus Pipeline per il trasporto del gas attraverso Azerbaigian e Georgia fino alla Turchia. In Turchia, il gas proseguirà la sua corsa verso ovest attraverso la Trans Anatolian Pipeline (Tanap), al momento in costruzione (terza fase). Infine, la Trans Adriatic Pipeline (Tap), di futura realizzazione, dovrebbe convogliare parte del gas in Italia attraverso Grecia, Albania e Mar Ionio (quarta fase). Il costo dell’opera è stimato intorno ai 45 miliardi di dollari. Le esportazioni di gas attraverso il Corridoio Meridionale dovrebbero cominciare entro il 2020, raggiungendo un tetto di 16 miliardi di metri cubi all’anno intorno al 2025. Si tratta di volumi modesti, praticamente dimezzati rispetto a quelli inizialmente auspicati dalla Commissione europea col progetto Nabucco (tramontato definitivamente nel 2013 e sostituito da quello descritto sopra). Inoltre, 6miliardi di metri cubi sono destinati al consumo in Turchia e solo 10 raggiungerebbero l’Ue. Per un raffronto, nel 2015 la Russia ha esportato in Europa e Turchia oltre 158 miliardi di metri cubi di gas. Utilizzando le infrastrutture già esistenti, Mosca potrebbe aumentare ulteriormente le sue esportazioni, creando un surplus che determinerebbe un calo dei prezzi e ridurrebbe la già discutibile redditività del Corridoio Meridionale. Le crescenti importazioni di gas naturale liquefatto in Europa contribuirebbero ulteriormente a questo trend. I sostenitori del Corridoio Meridionale talvolta argomentano che la capacità del progetto potrebbe essere incrementata fino a 32 miliardi di metri cubi l’anno. Al momento, questo appare impossibile se non si trovano altri fornitori di gas oltre all’Azerbaigian, che potrebbe perfino trovarsi in difficoltànel garantire i 16 miliardi di metri cubi all’anno già venduti. Le due opzioni più probabili per le forniture aggiuntive sarebbero il Turkmenistan e l’Iran. In entrambi i casi, l’ulteriore distanza e l’infrastrutturazione necessaria sembrano ostacoli pressoché insormontabili dal punto di vista economico. Per ottenere il gas turkmeno, l’Ue dovrebbe anche affrontare l’agguerrita concorrenza cinese e convincere gli stati con sbocco sul Mar Caspio (Russia e Iran compresi) a determinare lo status legale del bacino, attraverso il quale dovrebbe essere costruito il gasdotto di collegamento col Turkmenistan. Nagorno-Karabakh, rischi energetici del conflitto Progettato per contribuire alla sicurezza energetica europea, il Corridoio Meridionale potrebbe in realtà diventare fonte d’insicurezza a causa delle dispute geopolitiche nei territori attraversati. La più grave è quella relativa al Nagorno-Karabakh, una regione contesa militarmente da Armenia e Azerbaigian da quasi trent’anni, a pochi chilometri dalla South Caucasus Pipeline. Il rischio di un ampio conflitto nell’area è aumentato notevolmente negli ultimi anni, durante i quali i contendenti hanno moltiplicato le spese militari. Nell’aprile del 2016, le tensioni sono sfociate in quattro giorni di guerra. Nel caso di un futuro conflitto, l’Armenia potrebbe condurre attacchi aerei (già simulati nel recente passato) o missilistici (resi possibili dal recente acquisto di missili Iskander, Scud-B eTochka-U dalla Russia) contro le infrastrutture energetiche azere. L’Ue e il rischio di dipendenza energetica da Paesi autoritari Il Corridoio Meridionale aumenterebbe la dipendenza energetica europea da Paesi autoritari. L’Azerbaigian, unico fornitore certo di gas destinato al progetto, è stato descritto in una recenterisoluzione del Parlamento europeo come il Paese che negli ultimi dieci anni ha subito il più grande declino in termini di governance democratica in tutta l'Eurasia. Freedom House ha inoltre specificato che la realizzazione del Corridoio Meridionale rafforzerebbe finanziariamente il governo repressivo e corrotto del Presidente azero Ilham Aliyev. La Turchia diventerebbe un importante Paese di transito per le forniture energetiche europee, aumentando ulteriormente il suo potere contrattuale con l’Ue. Viste le tendenze autoritarie del presidente turco e i suoi recenti tentativi di usare questioni come quella dei rifugiati nei negoziati con Bruxelles, i leader europei farebbero bene a chiedersi se è opportuno creare una nuova forma di dipendenza dalla Turchia. Ultime, ma non meno importanti, sono le questioni ambientali. Al di là del considerevole impatto ambientale dell’opera, appare inopportuno che l’Ue sostenga - anche finanziariamente, tramite fondi pubblici concessi attraverso la Banca europea degli investimenti - un progetto dai costi notevolissimi e destinato allo sfruttamento di combustibili fossili. A questo proposito, è importante ricordare che l’Energy Roadmap 2050 impegna l’Ue a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’80-95% rispetto ai livelli del 1990. Questo obiettivo potrà essere raggiunto solo se i limitati fondi disponibili vengono investiti nell’efficientamento energetico e nello sviluppo delle energie rinnovabili. Marco Siddi, Finnish Institute of International Affairs. | ||||||||
Storia Militare Briefing Il Fucile d'Assalto M16 e Derivati
-
SEGNALAZIONI LIBRARIE
La Rivista è parte integrante della Emeroteca del CESVAM
22 ore fa











































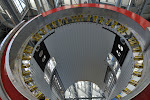












.jpg)



